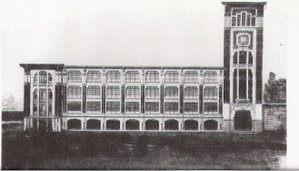Archeologia
industriale
La Fornace Penna di Sampieri fu realizzata tra il 1909 ed il 1912. Andò distrutta nel 1924 in seguito ad un incendio doloso. È stata utilizzata come set cinematografico per alcune riprese dello sceneggiato televisivo Il Commissario Montalbano. È in attesa di interventi urgenti di salvaguardia
L'ex Cotonificio Muggiani a Rho (Milano) edificato nel 1903 è stato uno dei più importanti opifici per la filatura del cotone in Italia. Chiuse i battenti nel 1963. Ad oggi è stato ristrutturato solo in parte
Un antico opificio dismesso a Chiavazza (periferia orientale di Biella), chiaro esempio di archeologia industriale. Assieme ad altre strutture industriali della zona fa parte del parco archeologico industriale pensato e strutturato lungo la Valle del torrente Cervo dall'architetto Gae Aulenti
L'archeologia industriale è un metodo interdisciplinare che studia tutte le testimonianze, materiali e immateriali, appositamente create al fine di attuare processi industriali od originatesi a causa di questi, al fine di approfondire la conoscenza della storia del passato e del presente industriale.
Le testimonianze attraverso cui l'archeologia industriale può giungere a questa conoscenza sono i luoghi dei processi produttivi, le tracce archeologiche causate da questi, i mezzi e i macchinari attraverso cui questi processi si sono attuati, i prodotti di questi processi, tutti le fonti scritte a loro inerenti, le fonti orali e i paesaggi segnati da questi processi e perciò detti paesaggi industriali.
Il periodo studiato dall'archeologia industriale è quello che va dalla seconda metà del Settecento ai giorni nostri, e più precisamente quello della rivoluzione industriale; tuttavia, questa disciplina prende in considerazione anche talune forme d'industria sviluppatesi prima di questo intervallo di tempo, e cioè le attività preindustriali e protoindustriali.
Origine dell'archeologia industriale
L'archeologia industriale quale disciplina di studio nasce nella prima metà degli anni cinquanta in Inghilterra. L'espressione archeologia industriale venne usata per la prima volta nel 1955 da Michael Rix, professore dell'Università di Birmingham, in un suo articolo pubblicato nella rivista The Amateur Historian. In realtà, come hanno precisato alcuni studiosi, tra cui Neil Cossons, questa espressione circolava già da qualche anno nei primi circoli di appassionati formatisi in Gran Bretagna.
L'Inghilterra, nella seconda metà del Settecento, era stata tra le prime nazioni ad essere coinvolta dalla rivoluzione industriale, e sin dalla seconda metà dell'Ottocento ebbe modo di svilupparsi in determinati ambienti culturali una certa attenzione per alcune testimonianze dell'industrializzazione. La Grande Esposizione Universale di Londra del 1851 fu uno dei primi momenti in cui tale sensibilità ebbe modo di manifestarsi; a questo seguì la creazione del Museo della Scienza di Kensigton qualche anno più tardi e tra la fine del secolo e l'inizio del Novecento il fiorire di una moltitudine di associazioni di appassionati, i trusts, con lo scopo di conservare alcuni monumenti industriali. Tra questi, grande importanza ebbe la Cornish Engine Preservation Society, nata con lo scopo di conservare i mulini ad acqua sorti nelle campagne inglesi.
Dopo la seconda guerra mondiale, l'opera di ricostruzione nella quale furono coinvolte le principali città del Regno Unito, a partire da Londra, portò alla distruzione di numerosi edifici e strutture che avevano avuto importanza nel Settecento e nell'Ottocento per l'evoluzione economica, industriale e sociale del Paese e che alla fine degli Anni Quaranta non avevano più nessuna utilità. Alla loro demolizione si opposero associazioni di cittadini, che vi vedevano una traccia importante del proprio passato. In particolare, nel 1962 l'attenzione dell'opinione pubblica fu attirata dalla decisione di demolire la Euston Station, una delle più antiche stazioni ferroviarie di Londra, e il portico di colonne doriche che la precedeva, lo Euston Arch. Nonostante le vive proteste dei comitati e della Comunità Internazionale, l'abbattimento della stazione fu inevitabile, seguito da un comune vivo risentimento. L'insuccesso di questo provvedimento portò, l'anno seguente, a dichiarare il ponte di ferro sul fiume Severn, in località Coalbrookdale, nel Galles, monumento nazionale. Il patrimonio di archeologia industriale veniva così ufficialmente riconosciuto nella sua importanza culturale dalle autorità anglosassoni.
Esempi
di patrimonio di archeologia industriale
Comunemente si sostiene che l'archeologia industriale debba riguardare fabbriche, siti industriali et similia relativamente recenti, e in quanto tali non necessitanti delle tecniche comunemente usate dall'archeologo tradizionale. Infatti si dice - che per le conoscenze intrinseche al manufatto, opificio, ecc. - l'archeologia industriale essa sia piuttosto una scienza per ingegneri ed architetti.
È vero, tuttavia, che in certi interessanti e meritevoli casi strutture industriali (officine, opifici, ecc.) siano stati in questi ultimi decenni riscoperti, restaurati e rivalutati in modo da divenire contenitori per centri studi e poli museali (come nel caso dell'ex fabbrica tessile Pria di Biella, al centro negli anni novanta di un importante progetto di recupero in chiave archeologico-industriale da parte dell'architetto Gae Aulenti o come nel caso della fabbrica Campolmi a Prato che ospita il Museo del Tessuto), centri commerciali o espositivi come Le Ciminiere di Catania, ecc., cosa impensabile per un sito archeologico tradizionale. Sotto questo aspetto, è evidente come la mano ingegneristico-architettonica risulti determinante.
Si pensi, tra gli altri, al caso italiano del Lingotto di Torino, storico stabilimento di produzione FIAT o, a Parigi al Museo della Gare d'Orsay, ex stazione ferroviaria. Si pensi anche all'ex zuccherificio di Cecina, Livorno.
Si ritiene che l'archeologia industriale possa avere in futuro un sicuro sviluppo. Questo presupposto muove dalla considerazione che tanto in Europa quanto nelle Americhe si assiste ad un sempre maggiore interesse per gli aspetti dell'industrializzazione che vengono - con il passare del tempo - visti in chiave maggiormente storica.
Lo stesso rilievo che sempre più si è dato in questi ultimi anni alla creazione degli Ecomusei ne è un ulteriore conferma essendo questi spesso collegati, nei maggiori centri urbani o nei loro pressi, alla rivalutazione ed alla divulgazione alle giovani generazioni della primigenia fase di industrializzazione conserviera, tessile, metalmeccanica, che contraddistingueva comunemente quelle zone in un passato non ancora remoto.
Tra i siti di notevole interesse in Lombardia si segnalano Crespi d'Adda - sito protetto dall'UNESCO - il Cotonificio Muggiani a Rho ed il corso del fiume Caldone (a Lecco) dove sono presenti sistemi idraulici per sfruttare l'energia dell'acqua. Questi sistemi servivano a fornire energia alle numerose officine che lavoravano materiale ferroso nate e sviluppatesi nell'Ottocento. Un'alta area ad alta concentrazione di industrie antiche è la Valle del fiume Olona, in Provincia di Varese.
Merita di esser citata, infine, Schio soprattutto grazie ai vari lanifici storici ubicati nel centro urbano (lanificio Cazzola, lanicio Lora (resti), Lanerossi -con la celebre Fabbrica Alta-, lanificio Conte), tutti fondati lungo il tracciato della Roggia Maestra, un canale artificiale indispensabile per produrre energia. Accanto a questi antichi opifici sorgono altri interessanti manufatti quali ad esempio il Nuovo quartiere operaio; sparse nel territorio comunale esistono altre interessanti testimonianze (stabilimento Italcementi, fabbrica Saccardo ed essiccatoi di caolino al Tretto, filanda Bressan a Magrè, eccetera).
La
Provincia di Treviso interviene con questa iniziativa su un tema di grande
interesse che a mia memoria non era mai stato affrontato prima da una pubblica
amministrazione nel territorio trevigiano.
Negli ultimi anni questa amministrazione, attraverso gli interventi e gli Studi
del Settore Beni Ambientali e Territoriali, ha posto l'attenzione sui siti di
Archeologia Industriale, realizzandone una mappatura che pur non essendo ancora
dei tutto definitiva, può dare fin d'ora la possibilità agli studiosi di farsi una
chiara idea della quantità e della rilevanza dei siti industriali d'epoca. Oggi
l'Archivio Fotografico Storico della Provincia ha avviato una campagna di
recupero dei documenti fotografici relativi alle vecchie fabbriche: era
indispensabile intervenire prima che tutto andasse disperso.
Moltissimi proprietari di industrie e collezionisti hanno raccolto l'appello
per una salvaguardia di questi documenti.
Proprio le vecchie foto, che testimoniano la vita in fabbrica e l'evolversi
della tecnologia nei processi produttivi, stanno divenendo in questi anni
strumenti insostituibili per studiare questa materia. Nell'arco di un secolo il
rapido evolversi della società ha reso sorpassati i modi di produzione: oggi a
noi spetta la difficile operazione culturale di tutelare le strutture e le
testimonianze della cultura imprenditoriale e del sapere operaio che furono
alla base dei grande balzo in avanti dell'economia e dell'industria.
Gli edifici di un certo interesse per l'archeologia industriale nella Marca
sono numerosi: basti citare la filanda Motta di Mogliano,
la filanda di Collalto a Susegana,
il canapificio di Crocetta, la fonderia di Santa Maria del Rovere, il molino Mandelli alla Fiera, le fornaci da calce (calchere) come quelle di Spresiano,
Crocetta e l'antica fornace degli Appiani, o l'altra altrettanto importante dei
Guerra-Gregorj che produsse laterizi e ceramiche.
Edifici ricchi di storia, come quest'ultima fornace, ad esempio, che ebbe
origine nel primo '800: qui venne costruito uno dei primi forni Hoffmann e di qui uscirono i mattoni impiegati per
ricostruire il campanile di San Marco, dopo il suo crollo, e anche i mattoni
con i quali si edificarono gran parte dei campanili dei trevigiano e veneziano.
Oggi forse è tardi, ma dobbiamo ugualmente intervenire al più presto per
salvare, ove possibile, gli edifici e le immagini dell'archeologia industriaIe.
>Ubaldo Fanton, Assessore alla Cultura
Provincia di Treviso
E' con particolare entusiasmo e vivo interesse che l'Amministrazione Comunale
di Villorba, congiuntamente alla Provincia di
Treviso, ha dato vita a questa iniziativa sul tema dell'Archeologia
Industriale.
Villorba ha visto insediati, nel suo territorio
numerosissimi opifici, trasformatisi nel corso dell'Ottocento in industrie di
rilievo anche nazionale, come la Cartiera Marsoni ed
altre. Pertanto ancora numerosi ed evidenti, nel nostro territorio, i segni
lasciati da questa intensa attività industriale: la Cartiera Marsoni anzitutto, insediamento produttivo da oltre
trecento anni, la Cartiera Brunelli a Fontane, il
Pastificio Bettiol, la Fornace di Lancenigo ecc.
Negli ultimi decenni tale vocazione produttiva si è ulteriormente consolidata,
dando vita ad una dinamica e capillare diffusione di attività e di servizi.
L'idea di realizzare un convegno e una mostra su un tema di così ampio
interesse è nata ed è maturata proprio qui a Villorba,
dalla consapevolezza che la realtà produttiva, sia di ieri che di oggi, non può
prescindere da un corretto impatto ambientale, né da una sua funzione
socio-culturale.
Per queste ragioni siamo convinti che sia necessario porsi il problema di una
equilibrata transizione delle aree industriali al momento della loro disimissione, senza cancellarne del tutto la memoria nel
territorio.
Per Villorba, oggi, la ciminiera della Cartiera Marsoni è un simbolo del lavoro, la radice di una diffusa
ricchezza, un elemento importante della storia stessa del paese.
Abbiamo avuto modo di constatare quanto sia radicata nella gente di Villorba la storia e la presenza di questa industria, soprattutto
in occasione dei recenti incontri con gli ex operai che ci hanno dato lo
stimolo per realizzare il convegno e la mostra fotografica. Da tali incontri è
emerso uno spaccato della storia villorbese, quella
più vera e autentica, ma soprattutto il legame affettivo che unisce gli ex
operai e le loro famiglie con una fabbrica che li ha riscattati dalla miseria
che opprimeva questa nostra zona nel dopoguerra, evitando loro l'emigrazione e
il conseguente sradicamento sociale.
Quale il mio auspicio? Che in futuro, quando si porrà il problema di un riammodernamento di certe parti di questa industria, si
abbia la sensibilità e la cultura di mantenerne i tratti significativi nella
loro genuinità.
Giovanni Fontana, Assessore alla Cultura Comune di Villorba
IL FONDO FOTOGRAFICO SULL'ARCHEOLOGIA
INDUSTRIALE DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO
La
risposta da parte di ex-proprietari, collezionisti, utenti alla nostra
richiesta di collaborazione per la costituzione di un Fondo Fotografico
sull'Archeologia Industriale ci ha piacevolmente sorpreso: quasi un migliaio di
foto sono state infatti inoltrate alla riproduzione fotografica e digitale per
il successivo inserimento nella banca immagini dell'Archivio Fotografico
Storico.
Inizia ora una parte non meno difficile nel lavoro di catalogazione delle
immagini che ci sono pervenute: spesso rimangono infatti ancora da completare i
campi-scheda, un lavoro per il quale ci attendiamo la collaborazione delle
tante persone che gentilmente ci hanno concesso il materiale fotografico.
L'interesse suscitato dall'iniziativa negli studenti universitari, storici,
architetti è stato notevole e sono immediatamente giunte numerose le richieste
di consultazione dei Fondo in costituzione. Ovviamente il Fondo Fotografico
così com'è attualmente non può considerarsi completo, mancando alla sua
completezza immagini di numerosi edifici di Archeologia Industriale pur
presenti in passato o ancora oggi nel territorio: si procederà dunque anche in
futuro a una sua implementazione .
L'Archivio Fotografico Storico è al servizio degli studiosi: da essi ci si
attende ovviarnente collaborazione e attenzioni per
un arricchimento e catalogazione dettagliata di questo nuovo Fondo Fotografico
Importante si è rivelata poi l'iniziativa di collaborazione con il Comune di Villorba per la raccolta di immagini sulla Cartiera Marsoni, edificio attualmente in funzione con settori
modernissimi, a fianco dei quali tuttavia permangono edifici e attrezzature
obsolete, relative a procedimenti industriali non più attivi, di notevole
interesse per l'Archeologia Industriale.
Nell'ambito di questa collaborazione è stato possibile raccogliere le preziose
testimonianze degli anziani operai che hanno documentato l'attività della
Cartiera Marsoni dagli anni '20 agli anni '60:
testimonianze che hanno reso vive e parlanti le foto d'epoca di questa
fabbrica.
L'operazione Archeologia Industriale è solo una delle iniziative che l'Archivio
ha intenzione di avviare nel territorio: in futuro l'attenzione si sposterà
anche su temi diversi, come ad esempio le immagini inerenti i momenti dell'arte
e dello spettacolo, sul teatro, sulla musica e su tutti quei momenti
"effimeri" nei quali musica, gestualità e scenografia si fondono in
sintesi spesso irripetibili.
La dispersione dei documenti fotografici dei momenti dell'arte e dello
spettacolo nel Veneto è una realtà: li troviamo confinati, spesso, nelle
raccolte privatissime del tal collezionista, artista, compagnia o, nel migliore
dei casi, fotografo.
Adriano Favaro, Direttore del F.A.S.T.
La piccola Valle Imperina, che si apre qualche chilometro a sud di Agordo, è stata nei secoli passati, uno dei maggiori centri minerari del Veneto. L’attività estrattiva, documentata per la prima volta nel 1417, è proseguita ininterrottamente fino al 1962. Il monumento senza dubbio più significativo è costituito dall’edificio dei forni per la fusione e la raffinazione del rame.
Questi ultimi, simbolo di un’attività mineraria durata per oltre cinque secoli, esercitano sull’osservatore una profonda suggestione. Costruiti in solidi blocchi di scisto verdastro, sembrano sfidare i decenni se non i secoli. Significati storici e culturali e valenze estetiche convergono qui in quello che costituisce senza dubbio uno dei più notevoli monumenti industriali dell’area veneta.
L'ARCHEOLOGIA
INDUSTRIALE / IL MAGLIO DI PAGNANO
Il maglio di Pagnano, un esempio di architettura proto-industriale
Pagnano, la frazione più prossima ad Asolo, sorge alla confluenza dei due torrenti Muson ed Erega. Grazie alla presenza dell’acqua nell’area di insediamento furono realizzati diversi mulini ad acqua, alcuni dei quali ancora esistenti. Tra essi il Maglio di Pagnano, edificato nel 1474.
La presenza di questo antico edificio è di notevole interesse non solo perché funge da esempio di archeologia industriale ma anche perché rappresenta una caratteristica peculiare di tutto il territorio della Marca, essendo i mulini ad acqua (adibiti a diverse funzioni) numerosissimi. Il maglio di Pagnano, restaurato di recente, conserva ancora la distribuzione interna originaria: il maglio, le mole, la tromba idroeolica che soffia l’aria sulla forgia e i mantici
L'ARCHEOLOGIA
INDUSTRIALE / L'ANTICA LATTERIA A CASTELCUCCO
D'ASOLO
Dall’allevamento ai prodotti caseari, l’antica produzione del morlacco
La Premiata Latteria Sociale Cooperativa Lungo Muson nasce nel 1921, fondata da 14 soci di Castelcucco d’Asolo e dei comuni vicini con il nome originario di “Latteria Redenta”, allo scopo di fabbricare derivati del latte. Le prime attrezzature acquistate furono una scrematrice ed una zangola.
La Latteria sorge in prossimità del torrentello Muson, la cui portata idrica è sufficiente a muovere l’albero motore principale, che tramite pulegge e cinghie di trasmissione metteva in movimento miscelatori, zangole, presse. Con l’ausilio delle macchine e la forza di volontà di decine di uomini e donne, nell’antica Latteria si produceva burro, formaggio mezzo grasso, chiamato bastardo, ed il ben più famoso morlacco.
Archeologia industriale
Il Porto di Treviso a
Silea
Dopo la Guerra 40-45, con la ripresa delle attività civili, il
problema del porto fluviale della città di Treviso, fu finalmente affrontato.
Venne fondato, nell'ottobre del '45, da Comune, Provincia e Camera di
Commercio. Il Consorzio Portuario di Treviso che incaricò l'Ing. Giuseppe Stancari di redigere un progetto per la creazione di un
porto fluviale con annessa area industriale. In circa due anni il progetto fu
pronto e prevedeva tra l'altro il collegamento del neo porto fluviale a Silea
con la ferrovia Treviso-Motta per mezzo di un
raccordo lungo 3 Km. I lavori proseguirono sino al 1950 sotto la direzione del
Genio Civile. La realizzazione di quest'opera, impegno molta manodopera e in
quegli anni di disoccupazione e miseria, dettero sostentamento alla locale
popolazione. Furono completate le strade di accesso al porto, costruite le
banchine e la conca di navigazione da 300 t. a valle del taglio del Sile.
Veniva completata in quegli anni anche la centrale idroelettrica (entrò in
funzione nel 1954). Il grande complesso portuale industriale che i giornali
descrissero come "la più grandiosa opera pubblica della provincia" si
fermò per sempre e l'Ente gestore, il Consorzio Portuario di Treviso,
sopravvisse sottotono per alcuni anni ancora.
Lo
Squero e i Cantieri Navali
L'artigianato e l'industria cantieristica
Attivo negli anni '30, in prossimità del cimitero dei burci,
vi era lo squero artigianale dei Vezzà, qui gli squeraroli riparavano le barche che percorrevano il Sile,
tra queste ricordiamo: la Salute, la Favorita, l'Umberto, la Elisabetta, la
Costanza. A Casier furono attivi, negli anni venti e con un imponente struttura
produttiva, i Cantieri del Levante - Salpanavi, che
arrivarono ad occupare oltre 200 persone. Inizialmente di proprietà Ronfini (Officine Meccaniche Trevigiane), i Cantieri del
Levante si trasformarono in S.P.A. con sede a Milano.
Qui si costruivano motonavi in ferro di notevole portata (intorno ai 4000
quintali), le quali la navigazione, per poter passare sotto il ponte di Quarto
d'Altino, venivano zavorrate con forti quantitativi
di ghiaia. Durante l'ultima guerra mondiale, con l'occupazione dei nazisti, i
partigiani sabotarono più volte il cantiere . L'azione più significativa fu
l'affondamento (d'accordo con la proprietà) di due grandi imbarcazioni commissionate
dai tedeschi, nella notte del 16 dicembre 1944. L'ultimo varo di cui si ha
notizia (pare il sedicesimo) fu quello della motonave Frances.
Il Gazzettino del 4 aprile 1948 racconta che "presente tutta la
popolazione di Casier" il varo venne benedetto dal parroco don Antonelli e
la madrina fu un impiegata del Cantiere certa Elsa Zanchetta.
Di li a pochi anni, i cantieri conclusero la loro attività, e al loro posto
sorse, intorno al 1957, la "Sile, costruzioni termoidrauliche".
L'isola di Villapendola e la
ribellione del Sile
Quando, nell'aprile del 1954 il direttore dei lavori ing. Ceccotto dette l'ordine di rovesciare massi e rocce sul
fondo del Sile, per innalzare una diga nel punto in cui doveva avvenire la
diversione nel nuovo taglio, lungo un chilometro tutto dritto e che avrebbe
consentito alle imbarcazioni di evitare cinque chilometri di tortuoso e stretto
percorso, il Sile non voleva proprio saperne e si infrangeva furiosamente
contro le rocce tanto che "…el fasséa paura". Numerosi uomini e macchinari avevano
scavato un grande canale, largo mt. 20 a monte e 34 a
valle della centrale idroelettrica, che iniziava dal porto di Silea, sino al Vòlto dee Lavandère in località
Fiera; l'opera avrebbe consentito una navigazione più celere e di portata maggiore,
consentendo il passaggio di imbarcazioni più grandi, come le bettoline. Ci
volle un bel po' per vincere l'ostinazione del fiume che, innalzato di 80 cm.
si decise di deviare finalmente sul nuovo canale costruito dall'uomo, riducendo
la portata del vecchio tracciato, che da allora fu chiamato Sile Morto. Il
lavori di scavo, che durarono 4 anni, iniziarono nell'ottobre del 1950, e si
conclusero nell'aprile del 1954. La realizzazione del canale creò un isola
artificiale che prende il nome di Isola di Villapendola.
La Centrale idroelettrica di Silea di proprietà: della Elettroburgo
Spa (Cartiere Burgo). E' in funzione dal 1954. Sfrutta un salto d'acqua di mt. 3,80. Azionata da due turbine Kaplan
produce 1750 Kwh. Rendiamo
finalmente agli artigiani la giustizia loro dovuta. Le arti liberali si sono
già cantate abbastanza da sole: oggi potrebbero ben impiegare la loro voce a
celebrare le arti meccaniche». Così nell’Enciclopedia, Denis Diderot precorreva i tempi con la sua filosofia del lavoro
manuale e meccanico.
Oggi invece, iniziando dagli anni ’70 con la crisi della grande industria e la dismissione dei grandi complessi industriali siderurgici, meccanici, chimici e petroliferi, in Italia nasce il problema delle aree industriali dismesse. In pochi anni la questione assume un rilievo sempre più importante perché si innescano processi di degrado fisico, ambientale ed anche sociale, che rischiano di deprimere intere parti di città. Si pone quindi il problema della riconversione, analogamente a quanto avvenuto in Inghilterra, nella seconda metà dell’800, con la prima crisi della città industriale. Con la svolta degli anni ’90, sul piano urbanistico, la questione delle aree industriali dismesse, in prospettiva può diventare una risorsa importante per il processo di rinnovo della città (vedi zona Eden a Treviso). Da un recente Convegno (giugno 2000 a Prato) dal tema “Il Patrimonio Archeologico Industriale: possibili sviluppi nel Veneto” si evidenzia la necessità di provvedere all’identificazione dei manufatti archeologici industriali all’interno di ambiti e itinerari, i cui valori storici e ambientali impongono di intervenire con appositi strumenti progettuali. In questo piano tutti i Comuni del Veneto vengono indirizzati a individuare “i siti archeologici industriali” su aree più o meno estese e a stabilirne tutela e valorizzazione.
Nel trevigiano una prima mappatura attesta circa 354 siti archeologici e industriali in 78 ambiti comunali, concentrati lungo corsi d’acqua quali il Meschio, la Piavesella e lo stesso Sile.
1. A Pagnano d’Asolo una antica fucina del XV sec., il cui maglio azionato dall’acqua del torrente Musone ha funzionato fino a tempi recenti, è stata recuperata e riattivata dal Comune di Asolo.
2. Sempre alle pendici dei colli asolani una fornace, gestita oggi dalla Confartigianato di Asolo, è stata restaurata con correttezza filologica mantenendo integro il largo ambiente rotondo per la cottura dei laterizi.
3. Infine, a Campocroce di Mogliano Veneto vi è la Filanda Motta.
1. Il Maglio di Pagnano
d’Asolo
In località Pagnano, alle falde dei Colli Asolani, in provincia di Treviso, scorre il torrente Musone, che nasce poco più a monte per effetto carsico, dalla Pedemontana.
La forza cinetica dell’acqua del Musone venne utilizzata fin dal medioevo per attivare il maglio di Pagnano d’Asolo, la cui struttura primaria, sfidando i danni del tempo e il processo di evoluzione tecnologica, si è mantenuta integra fino ad oggi.
È stato soggetto ad interventi di restauro conservativo che ne ha lasciato integro tutto l’impianto: il forno, il maglio, la mola e l’intero edificio dalla tipologia muraria mista, in ciottoli fluviali, pietra e mattoni.
Nella canaletta che bagna l’edificio l’acqua del Musone è convogliata fino al salto d’acqua e alle chiuse, adibite al controllo della quantità d’acqua e della velocità.
Vengono pertanto azionati sia il maglio – un grosso martello di legno a due teste – sia la mola per aguzzare e affilare le lame di ferro.
Scendendo i pochi gradini che immettono ai vani del maglio il visitatore viene subito avvolto da una penombra accentuata dalle pareti annerite, vecchie di secoli, che ricordano l’intensa attività artigianale svolta in questa fucina.
Nacque infatti nel XIII secolo, in un territorio già appartenente all’Ager centuriato dell’antico Municipio romano di Acelum (Asolo): in effetti il ponte sul torrente che conduce al maglio riporta una lapide che documenta l’origine romana.
L'antica tipologia muraria La canaletta e le chiuse


Qui il “majaro” svolgeva la sua attività e così è stato ininterrottamente fino a circa vent’anni fa.
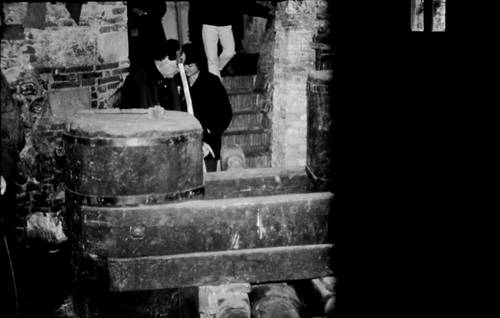
Il maglio
L’ultimo fabbro ad avervi lavorato ha mantenuto vivi il maglio, il forno, la mola e tutti gli altri macchinari che oggi funzionano per gruppi in visita.
In alcuni locali di recente ristrutturazione, adiacenti al maglio, sono esposti vari oggetti e un interessante archivio contenente documenti risalenti fino al 1600.

Le antiche strutture azionate dal Musone
2. Fornace di Asolo
È un forno Hofman quello di Asolo, chiamato così dal nome del tedesco inventore di questa tipologia di forno per la cottura di laterizi di ogni genere.
 La struttura della fornace è costituita da un anello
ellissoidale con copertura a volte a botte, tutta in mattoni, dove venivano
distribuiti i prodotti sottoposti a cottura, e da una cavità al centro
costituita dal forno a carbone.
La struttura della fornace è costituita da un anello
ellissoidale con copertura a volte a botte, tutta in mattoni, dove venivano
distribuiti i prodotti sottoposti a cottura, e da una cavità al centro
costituita dal forno a carbone.
Tutti i laterizi erano lavorati all’aperto, modellati con l’argilla ricavata dalle vicine cave di Possagno, asciugati all’aria e poi coperti di frasche o canne.
Mattoni, tegole e altri prodotti, una volta persa l’umidità che avrebbe reso difficile la cottura, venivano trasportati mediante carrelli, trainati su rotaie, fino al vano del forno di cottura.
Oggi la fornace è stata inglobata in una struttura moderna che la tutela da eventuale rovina o degrado. Si può percorrere l’anello ellissoidale corrispondente al vano di cottura e salire fino all’altezza del forno e vederne la cavità.
La ciminiera indica il sito e la funzione industriale della struttura, anche se appare esternamente come una costruzione moderna, circondata da area verde.

Anello elissoidale del vano di cottura
3. La Società Anonima Industrie
Bacologiche e Seriche del cav. Pietro Motta
È questa la denominazione sociale con la quale lo stabilimento cessò definitivamente nell’anno 1953 la sua attività anche se questa si protrasse stancamente per altri due anni sotto forma cooperativistica (Cooperativa Trattura seta-Filanda Campocroce di Mogliano Veneto).
La storia di questa filanda, emblematica per motivi economici e sociali di un certo tipo di sviluppo industriale nel Veneto post-unitario, inizia nel lontano 1876 per opera di un intraprendente proprietario fondiario e ricco borghese veneziano, l’ing. Pietro Motta.
La famiglia Motta era proprietaria di una vasta zona di terreni agricoli (un centinaio di ettari) in località Campocroce di Mogliano Veneto nell’immediato entroterra veneziano dove aveva impiantato un’azienda agricola, cosa che si deduce in modo chiaro dalla struttura del primo corpo di edifici poi adibiti ad attività industriale.
L’attività che ben presto acquisì rinomanza, consisteva nella produzione e nella selezionatura di semi-bachi delle varie razze di bachi da seta. Accanto a questa attività di routine ne esisteva un’altra di ricerca vera e propria che portò dopo studi ed esperimenti con qualità provenienti dalla Cina e dal Giappone, alla produzione di una nuova razza detta Chinese dorato molto resistente alle malattie e pregiata.
Questa iniziativa si dimostrò proficua e consentì alla fine degli anni 1890 l’apertura di una prima filanda raggiunta da una seconda verso il 1904.
L’opificio cominciò sfruttando la forza vapore quale fonte di energia, impiegando dei motori che, a seconda della necessità, sviluppavano una potenza complessiva di 10 cavalli-vapore effettivi; solo nel 1904 si ha notizia dell’introduzione dell’energia elettrica che presumibilmente sino alla fine degli anni ‘20 fu abbinata alla forza-vapore.
I reparti adibiti a filanda erano dotati di impianti di aspirazione per il vapore presente durante la lavorazione dei bozzoli nelle bacinelle. L’acqua era attinta da un pozzo artesiano situato nella stessa area della filanda.
L’anno nero fu il 1934, dove le quotazioni della seta raggiunsero livelli minimi, (lire 32 al kg) che la filanda superò grazie ad una elevata capacità di adattamento alla crisi attribuibile allo stretto legame mantenuto con le campagne su cui scaricava l’intero onere in termine di riduzione dei salari e del prezzo dei bozzoli.
Per mancanza forse di volontà o di mezzi da parte della proprietà, passata nel frattempo ai figli dell’ing. Motta dopo un periodo di conduzione della madre rimasta vedova nel 1911, non si tentò l’introduzione alternativa delle fibre artificiali o miste che in qualche modo avrebbero potuto compensare questo trend negativo.
La grande sala della
filatura: esterno 
Si giunse così, alla metà degli anni ‘50, e dopo la scomparsa degli elementi più rappresentativi e validi della famiglia Motta e non essendoci dei naturali rincalzi, la filanda che per molti anni aveva dato lavoro a centinaia di operaie, portando nella zona un certo benessere, anche se modesto, chiuse i battenti.
A sua triste testimonianza, mancando tra l’altro perché inconsciamente distrutta o smarrita o, perché non più rintracciabile presso il Tribunale di Treviso dove fu dichiarata fallita, una valida documentazione d’archivio, rimane il complesso di edifici aziendali, interessante esempio di architettura industriale di fine secolo.
E fu concomitante la rapida diminuzione dei gelsi dalle campagne vicine non risultando più proficuo per il contadino la coltura del baco da seta.