Everest
|
Il monte Everest, parete sud-ovest |
|
|
Altezza |
8848 m s.l.m. |
|
Chomolangma (tibetano,
"madre dell'universo") |
|
|
Data prima ascensione |
|
|
Autore/i prima
ascensione |
Edmund Hillary e Tenzing Norgay |
|
Mappa di localizzazione |
|
|
|
|
Coordinate: 27°59′17″N 86°55′31″E / 27.988056°N 86.925278°E
Il Monte Everest è la più alta vetta della Terra, la sua altezza è di 8.848 metri. È situato nella catena dell'Himalaya, al confine tra la Cina e il Nepal.
Il monte è chiamato Chomolangma (madre dell'universo) in tibetano e Qomolangma (珠穆朗瑪峰 pinyin: Zhūmùlǎngmǎ Fēng) in cinese. Il nome nepalese è Sagaramāthā (सगरमाथा, in Sanscrito "dio del cielo"), ideato dallo storico nepalese Baburam Acharya e adottato ufficialmente dal governo del Nepal all'inizio degli anni sessanta. Nel 1852 venne chiamato "Cima XV".
Il nome comunemente usato oggi fu introdotto nel 1865 dall'inglese Andrew Waugh, governatore generale dell'India, in onore di Sir George Everest, che al servizio della corona britannica lavorò per molti anni come responsabile dei geografi britannici in India.
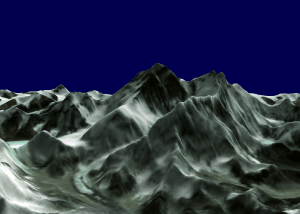
Everest 3D
Indice
|
Altezza dell'Everest
Dal 1850 al 1954 l'altezza si calcolava in 8.840 metri, poi esperti dell'India proposero un'altezza di 8.861 metri, con variazioni di tre metri a causa neve.
Tecnici cinesi nel 1975 stabilirono un'altezza di 8.848 metri.[1] Nel 1993 il CNR italiano suggerì un'altezza di 8.846 metri.
La misurazione fatta da satellite nel 2002 aveva dato un valore di 8.850 m s.l.m., valore utilizzato da allora su tutte le pubblicazioni e carte geografiche della National Geographic Society.
Nell'ambito della spedizione italiana del 2004 per il cinquantenario della prima salita del K2, fu effettuata una misurazione con GPS della quota di vetta, con un apparecchio sperimentale che permetteva di rilevare sia la quota della copertura nevosa, che la quota della roccia sottostante. I due valori ottenuti risultarono di 8.852 m per la sommità nevosa, e di 8.849 m per la sommità in roccia.[2]
Nel 2005, la Cina ha effettuato un'ulteriore campagna di rilevamento con GPS, fissando l'altezza della montagna a 8.844,43 m s.l.m., con un margine d'errore di 21 cm. Questa misura è riferita al punto più elevato su roccia, e quindi non tiene conto della copertura di neve e ghiaccio che ricopre la vetta. Il rilievo è stato effettuato rilevando la quota sommitale effettiva, misurando lo spessore del ghiaccio, e ricavando la quota della massima elevazione in roccia per differenza.[1] La copertura di ghiaccio è risultata essere di circa 3,5 m,[3] portando quindi la quota della vetta effettiva a 8.848 m.
Alpinismo
Storia
I primi tentativi di raggiungere la vetta dell'Everest risalgono al 1921, 1922 e 1924 quando furono organizzate delle spedizioni britanniche. Nel corso della spedizione britannica all'Everest del 1924, George Mallory ed Andrew Irvine scomparvero nel corso di un tentativo alla vetta dalla parete nord, quella più complessa. Mallory, il cui cadavere venne ritrovato decine di anni dopo, morì durante la discesa. Ma non è appurato se i due siano caduti dopo aver raggiunto la cima o, più probabilmente, a seguito della rinuncia al tentativo. Indizi potrebbero essere stabiliti se venisse ritrovata la macchina fotografica probabilmente in possesso di Irvine, il cui cadavere, però, è ancora disperso. Inoltre, Mallory annunciò che, nel caso in cui fosse riuscito a raggiungere la cima, vi avrebbe lasciato una foto della moglie, foto non ritrovata sul cadavere rinvenuto decine di anni dopo.
La cima fu raggiunta con certezza per la prima volta il 29 maggio 1953 dal Neozelandese Sir Edmund Hillary e dallo Sherpa Tenzing Norgay, che lo scalarono dalla parete sud. La scelta del versante sud fu obbligata poiché il versante nord era chiuso per questioni politiche da anni. Stando alle dichiarazioni successive di Tenzing, divenuto celebre in patria e nel mondo, il neozelandese giunse qualche secondo prima perché in quel momento stava battendo la traccia. Giunti sulla cima, in segno di ringraziamento, Hillary pose nella neve una croce mentre Tenzing biscotti e cioccolato. Rimasero sulla vetta un quarto d'ora. Edmund Hillary è morto a 88 anni l'11 gennaio del 2008, mentre Tenzing è mancato nel 1986, a 72 anni di età.
L'8 maggio 1978 Reinhold Messner e Peter Habeler raggiunsero per primi la cima senza l'ausilio di ossigeno.
A partire dagli anni ottanta la cima dell'Everest è diventata meta frequente di spedizioni commerciali. Il numero di alpinisti che conquistano la cima è aumentato sensibilmente. Lo svantaggio di questa massificazione della scalata dell'Everest è l'inquinamento ambientale da campi base. È anche proporzionalmente aumentato il numero di incidenti, spesso mortali.
Vie di ascesa
L'Everest ha due percorsi principali di ascesa: la parete sud, alla quale si accede dal Nepal e la parete nord, alla quale si accede dal Tibet.
Il percorso da sud è quello tecnicamente più semplice e anche più utilizzato. Fu il percorso scelto da Hillary e Norgay(i primi scalatori dell' Everest), il 28 maggio 1953; ai tempi la scelta fu costretta in quanto la frontiera tibetana era chiusa dal 1949.
Esiste però un'altra via di salita all'Everest, estremamente tecnica e difficile, che nessuno ha ancora tentato: la cosiddetta "Fantasy Ridge".
Le ascese vengono effettuate nel periodo primaverile prima dell'inizio del monsone estivo. In questo periodo si verifica anche una modifica della corrente a getto che provoca una riduzione della velocità media del vento in alta montagna. A volte vengono fatti dei tentativi di scalata nel periodo successivo al monsone estivo ma la presenza di neve rappresenta un ostacolo notevole.
La parete sud
Le spedizioni che pianificano un'ascesa della parete sud solitamente atterrano a Lukla (2.860 m) provenienti da Kathmandu e poi marciano fino al campo base che si trova in Nepal sul versante sud dell'Everest a quota 5.380 m. Il tempo di marcia varia dai sei agli otto giorni, necessari per acclimatarsi di modo da evitare il mal di montagna.
Le attrezzature e i rifornimenti sono trasportati dagli yak e dai portatori fino al campo base sul ghiacciaio del Khumbu.
Gli alpinisti trascorrono un paio di settimane al campo base per acclimatarsi all'altitudine. Durante questo periodo gli sherpa e alcuni alpinisti della spedizione installano le corde e le scale nel pericoloso ghiacciaio del Khumbu. Seracchi e blocchi di ghiaccio mobili lo rendono uno dei tratti più pericolosi dell'intera ascesa: molti alpinisti e sherpa, infatti, vi hanno perso la vita. Per ridurre il rischio, gli alpinisti di solito cominciano la loro ascesa prima dell'alba. Una volta che la luce solare raggiunge il ghiacciaio, il pericolo aumenta notevolmente. Sopra il ghiacciaio si trova il campo I, detto anche advanced base camp (ABC), a quota 6.065 m.
Dal campo I, gli alpinisti salgono sulla Western cwm fino alla base del Lhotse dove si trova il campo II a 6.500 m. Il Western Cwm è una valle glaciale formata dai versanti di Everest, Lhotse e Nuptse relativamente piana con una pendenza molto dolce, contrassegnata da enormi crepacci nel centro che impediscono l'accesso alle quote più elevate del Cwm. Gli alpinisti sono quindi costretti ad attraversare un piccolo passaggio conosciuto come "l'angolo di Nuptse" che si trova all'estrema destra vicino alla base del Nuptse. Il Western Cwm inoltre è denominato "la valle del silenzio" in quanto la topografia della vallata impedisce ai venti di raggiungere l'itinerario dell'arrampicata rendendo, soprattutto nelle giornate serene, il passaggio nel Cwm molto caldo e faticoso.
Dal campo II gli alpinisti salgono la parete del Lhotse con corde fisse fino a una sporgenza a quota 7.470 m. Da qui sono altri 500 metri fino al campo IV situato sul colle Sud. Qui si entra nella cosiddetta death zone (zona della morte), la zona in cui la rarefazione dell'ossigeno provoca ipossia. Gli alpinisti hanno al massimo due/tre giorni per tentare di raggiungere la cima. Le condizioni meteorologiche sono un fattore determinante, il cielo sereno e i venti moderati sono importantissimi per tentare la scalata. Se la scalata non è possibile è spesso necessario tornare fino al campo base.
Dal campo IV le scalate delle spedizioni commerciali partono intorno alle 20.00 della sera precedente con la speranza di raggiungere la cima (1000 metri più in alto) entro 10/12 ore, ma consentendo anche ai clienti più lenti di toccare la vetta prima di mezzogiorno, giudicata l'ora limite per un ritorno in sicurezza. La salita avviene dunque quasi completamente di notte, con l'aiuto di una torcia frontale, di una guida esperta che batte la traccia e delle corde fisse sistemate nei punti più pericolosi.
La prima tappa è il "balcone" a quota 8.400 m, un piccolo pianoro. I passaggi successivi sono una serie di gradini (tre step) con neve alta e forte rischio di valanghe, una pericolosa cornice con uno stretto passaggio molto esposto e un salto di roccia alto una decina di metri chiamato "Hillary Step" a quota 8.760 m. Fu infatti Hillary ad aprire la via in questo tratto durante la prima ascesa all'Everest. Lo step, lento da scalare, provoca imbottigliamenti e ritardi nei giorni in cui la montagna è molto frequentata ed è già successo che qualche alpinista abbia dovuto abbandonare il suo tentativo di vetta per l'eccessivo traffico in questo punto.
Superato il gradino è relativamente semplice giungere in cima. La discesa per tornare al campo IV deve essere immediata per evitare di incorrere nel maltempo tipico delle ore pomeridiane, perciò la maggior parte degli alpinisti resta sulla vetta solo pochi minuti!
La parete nord

Parete nord dell'Everest vista dal sentiero che porta al campo base in Tibet
Le ascese alla parete nord prevedono l'accesso all'Everest passando dal Tibet. Le spedizioni raggiungono il ghiacciaio Rongbuk e stabiliscono il campo base a quota 5.180 m su una piana di ghiaia ai piedi del ghiacciaio. Per raggiungere il campo II gli alpinisti salgono la morena a est del ghiacciaio fino ai piedi del Changtse a quota 6.100 m. Il campo III (ABC) è situato sotto il colle nord a 6.500 m. Per raggiungere il campo IV sul colle nord, è necessario attraversare, tramite corde fisse, il ghiacciaio ai piedi del colle nord a 7.100 m. Dal colle nord dopo una parete rocciosa si giunge al campo V a 7.775 m. Il percorso prevede l'attraversamento di una serie di burroni prima di raggiungere il campo VI a 8.230 m. Da qui per raggiungere la vetta si trovano una serie di gradini rocciosi superati i quali una ripida salita porta fino alla cima.
La via del versante tibetano è più tecnica rispetto a quello nepalese, oltre ad essere più esposta ai venti e a costringere gli alpinisti che la affrontano a stabilire un maggiore numero di campi nella zona della morte, ovvero sopra i 7800-8000 m.
Il campo base è servito da una strada che lo collega alla città di Tingri. Questa strada fu costruita dalla Cina negli anni cinquanta, ed è tuttora sterrata.[4] International Herald Tribune - completamento dei lavori sulla strada Tingri - campoi base
Statistiche
Alla fine del 2007 risultava che oltre 3.600 persone erano riuscite a raggiungere con successo la vetta dell'Everest,[5] e più di 200 vi avevano perso la vita.[6]
Cronologia
- 1921 La prima spedizione britannica esplora la salita del ghiacciaio Rongbuk.
- 1922 Sette Sherpa perdono la vita sotto una valanga, sono i primi morti durante una salita.
- 1922 La seconda spedizione britannica raggiunge quota 8.321 m.
- 1924 La terza spedizione britannica raggiunge gli 8.500 metri. Il 6 giugno, George Mallory e Andrew Irvine tentano la scalata per la vetta ma risultano dispersi dopo un brusco calo di visibilità. Testimoni oculari dichiarano di averli visti vicino alla cima.
- 1933 Lady Houston finanzia una formazione di aerei per il sorvolo della vetta.
- 1934 Maurice Wilson (Regno Unito) muore in un tentativo di scalata solitaria.
- 1950 Il Nepal apre le frontiere agli stranieri.
- 1952 Una spedizione svizzera alla quale si aggrega lo sherpa Tenzing Norgay abbandona il tentativo a circa 200 metri dalla vetta.
- 1953 La cima è raggiunta alle 11.30 del 29 maggio dal neozelandese Sir Edmund Hillary e dallo sherpa Tenzing Norgay dal Nepal scalando il colle sud.
- 1960 Il 25 maggio, una spedizione cinese raggiunge la vetta passando dalla parete nord.
- 1963 Primo attraversamento fatto da una spedizione statunitense che sale da ovest e scende da sud ovest.
- 1965 Il 10 maggio lo sherpa Nawang Gombu diventa la prima persona ad aver scalato la vetta per due volte.
- 1973 prima spedizione italiana diretta da Guido Monzino.
- 1974 Yuichiro Miura (Giappone) Prima discesa in sci.
- 1975 Il 16 maggio, Junko Tabei dal Giappone è la prima donna sulla vetta.
- 1975 Il 27 maggio, una donna tibetana, Phantog, diviene la prima donna a raggiungere la vetta dalla parte del Tibet.
- 1978 Reinhold Messner (Italia) e Peter Habeler (Austria) raggiungono la vetta senza l'uso di ossigeno.
- 1980 Prima spedizione invernale da parte di un team polacco.
- 1980 Reinhold Messner (Italia) è il primo uomo a scalare la vetta in solitaria e senza ossigeno.
- 1988 Jean-Marc Boivin (Francia) scende dalla vetta con il parapendio.
- 1990 Tim Macartney-Snape (Australia) è il primo uomo a raggiungere la vetta camminando e arrampicando dal livello del mare alla vetta dell'Everest.
- 1993 90 alpinisti scalano la vetta in autunno, comincia lo sfruttamento turistico della scalata dell'Everest.
- 1993 Ramon Blanco (Spagna) è la persona più anziana ad aver mai raggiunto la vetta. Ha 60 anni. (record battuto però nel 2003).
- 1996 Hans Kammerlander dell'Alto Adige (Italia), scala la parete nord in 16 ore e 45 minuti e scende con gli sci.
- 1996 Göran Kropp (Svezia) diventa la prima persona a raggiungere l'Everest in bicicletta partendo da casa, scalarlo senza ossigeno e tornare in bicicletta.
- 1998 Bear Grylls (Regno Unito) è il più giovane ad aver mai raggiunto la vetta. Ha 23 anni (record battuto però nel 2010).
- 1998 Tom Whittaker è il primo scalatore disabile a raggiungere la cima.
- 1999 Lo Sherpa Babu Chiri Sherpa del Nepal rimane sulla vetta per 21 ore.
- 2001 Il 24 maggio lo sherpa Temba Tsheri, 15 anni, diventa la persona più giovane mai salita in vetta.
- 2001 Il 25 maggio il 32enne Erik Weihenmayer di Boulder (Colorado), è la prima persona cieca a raggiungere la cima.
- 2001 Il 64enne Sherman Bull, di New Canaan, Connecticut, diviene la persona più anziana.
- 2003 Il 23 maggio, il 25enne sherpa nepalesese Pemba Dorjie Sherpa fa registrare il record di salita più veloce, 12 ore e 45 minuti, che verrà però successivamente migliorato.
- 2003 Il 23 maggio, Manuela Di Centa è la prima donna italiana in vetta.
- 2003 Tre giorni dopo lo sherpa Lakpa Gelu infrange il record con una salita di 10 ore e 56 minuti.
- 22 Marzo 2003 Yuichiro Miura è la persona più anziana: 70 anni.
- 2004 21 maggio, Pemba Dorjie Sherpa migliora il record di velocità. 8 ore e 10 minuti.
- 2005 Tra marzo e giugno una spedizione cinese composta da 35 cartografi ha corretto l'altezza dell'Everest rivedendola al ribasso. La montagna ora misura 8844,43 metri.
- 2007 Samantha Larson, diciottenne californiana, è la più giovane non nepalese a raggiungere la vetta[7] (lo sherpa Ming Kipa aveva raggiunto la cima a 14 anni nel 2003).
- 2008 L'8 maggio una spedizione di alpinisti cinesi è riuscita nell'impresa di portare la fiaccola olimpica di Pechino 2008 sulla vetta dell'Everest dopo alcuni precedenti tentativi falliti a causa delle avverse condizioni meteorologiche.[8][9][10]
- 2010 Il 13 maggio Jordan Romero, 13 anni, insieme al padre e a tre sherpa diventa il più giovane scalatore ad aver raggiunto la cima della montagna.[11]


