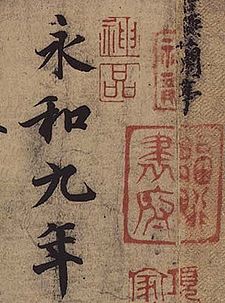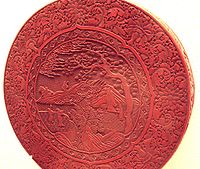Esercito di terracotta
L'esercito di terracotta Shaanxi province è
composto da 6.000 a 8.000 guerrieri di terracotta
(non lo si sa con certezza poiché gli scavi sono ancora in corso), vestiti con corazze in pietra e dotati di armi. Queste statue erano di
"guardia" alla tomba del primo imperatore cinese Qin Shi Huang. Di queste
statue sono state riportate alla luce solo 500 guerrieri, 18 carri in legno e
100 cavalli in terracotta). Tale sito
archeologico si trova vicino a Xi'an, nella provincia Shaanxi
della Cina.
Le ricerche archeologiche portarono alla luce, nel corso degli anni a
partire dal 1974,
fosse contenenti uomini di terracotta armati, carri, cavalli, statue
di servitori, mandarini, concubine e oggetti di vita quotidiana come vasi ed utensili.
Le statue rappresentano una minima parte del complesso archeologico che occupa
un'area di 56.000 metri quadrati.
Secondo la testimonianza dello storico cinese Sima Qian, nato un secolo dopo la
costruzione del mausoleo,
tale costruzione fu un vero e proprio affare
di stato, in cui lavorarono oltre 700.000 prigionieri
nel corso di 10 anni di lavoro.
La camera funeraria, non ancora portata totalmente
alla luce, sarebbe così profonda da attraversare 3 livelli di falde
acquifere, con pareti in bronzo e circondata da fiumi di cinabro, cioè solfuro
di mercurio che, per la filosofia taoista, sarebbe
un attivatore energetico per l'immortalità.
L'immortalità era una fissazione dell'Imperatore, che aveva organizzato
numerose spedizioni per terra e mare, alla ricerca del famoso elisir.
Ma Qin Shi Huang Di è
famoso anche per la costruzione della Grande
Muraglia, una fortificazione lunga migliaia di chilometri.
Quest'esercito
rappresenta una fedele replica dall'armata che aveva
unificato la Cina.
Tuttavia, nelle fosse, sono state trovate poche armi, poiché furono
saccheggiate dai ribelli che si insediarono sul trono imperiale: la dinastia
Han. Dalle posizioni delle mani e del corpo delle statue, possiamo però
immaginare le tecniche di combattimento di fanti, alabardieri,
arcieri e balestrieri. Si combatteva soprattutto a piedi; i
carri ed i cavalli servivano per dirigere i movimenti della fanteria. La cavalleria
fu introdotta più tardi, per affrontare i guerrieri nomadi che in
battaglia utilizzavano appunto i cavalli.
Le statue colpiscono inoltre per il loro realismo e nei
particolari: la tecnica usata per realizzarli consisteva nel compattare cerchi
di argilla in
modo da creare un tubo (il torace) e completate con l'aggiunta di gambe e braccio.
La struttura poi, veniva ricoperta di blocchetti di argilla per creare le uniformi e decorata
successivamente.
Nel 1987 il mausoleo
dell'imperatore Qin Shi
Huang Di, di cui l'esercito di terracotta fa parte, è stato inserito
nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.
Il 9 agosto
2007 venti esemplari
dell'esercito sono partiti via camion, assieme a circa un centinaio di altri
manufatti, per raggiungere il British Museum di Londra, dove sono
stati esposti dal 13 settembre 2007 al 6 aprile 2008.
Da luglio 2008 al
16
novembre 2008,
cinque dei guerrieri dell'esercito di terracotta di Qin
Shi Huangdi sono stati
esposti a Torino
presso il Museo di Antichità.
Dal 16 aprile 2010
al 5 settembre 2010
saranno esposti nove guarrieri a Milano, presso il Palazzo Reale, nella mostra dal titolo
"I due Imperi". Il gruppo è composto da un cavallo, un consigliere,
un balestriere e 6 lancieri.
Come molti altri
grandi ritrovamenti archeologici, l’esercito di terracotta di Xi’an fu scoperto per caso nel
1974 da contadini che, scavando il terreno, si imbatterono in strani pezzi di
terracotta modellata. Quei ritrovamenti hanno fatto la fortuna della città di Xi’an, una delle più grandi città
nella parte nord-occidentale della Cina, situata a sudovest
di Pechino (si raggiunge
con 16 ore di treno o più rapidamente in aereo).
L’esercito di terracotta fu voluto dall’imperatore Qin
Shi Huangdi, nato nel 259
a.C., lo stesso imperatore che unì la Cina, uniformò la grafia usata ancora
oggi e fece costruire la Grande
Muraglia cinese. Secondo le sue intenzioni, l’esercito che doveva
proteggere la sua monumentale tomba. Una mania di grandezza che in
realtà era solo specchio delle sue reali capacità: se l’imperatore
voleva lasciare ai posteri un’idea della sua grandiosità, ci è ben riuscito.
Dal 1987 il mausoleo di Qin Shi
Huangdi è stato anche inserito dall’UNESCO
nell’elenco dei Patrimoni dell’umanità.
L’esercito di guerrieri di terracotta, vestiti con corazze in pietra e
dotati di armi, è rimasto interrato per più di 2000 anni e costituisce solo una
minima parte del complesso archeologico, che occupa un’area vastissima e
rappresenta una fedele replica dall’armata che aveva unificato la Cina. Dei guerrieri oggi
si ammira soprattutto la bellezza dei volti,
diversi l’uno dall’altro, e volutamente. Infatti, gli artigiani erano stati
fatti arrivare da ogni parte del paese per compiere l’opera. I corpi venivano
modellati con argilla in strutture uniformi, ma i volti venivano rifiniti a
mano da ogni vasaio, che trasferiva in esso le caratteristiche della sua
regione di provenienza. Ed ecco il miracolo: tanti uomini diversi che da
millenni aspettano di combattere.
Per avere un’idea della loro bellezza, non c’è proprio necessario recarsi in
Cina, almeno per un altro mese, poiché fino al 16 novembre 2008 cinque
spettacolari guerrieri dell’esercito di terracotta di Xi’an sono esposti a Torino presso il Museo di Antichità.
Arte cinese
L'arte cinese è il complesso delle manifestazioni artistiche che hanno
origine nella Cina
antica e moderna o che vengono esercitate da artisti cinesi e costituisce
pertanto un'espressione della più ampia cultura
cinese.
Generalità
Diversamente che in "Occidente", la cui storia dell'arte ha
conosciuto in continuazione forti cesure nella forma a causa di mutamenti di stile,
l'arte cinese nel corso dei secoli è caratterizzata da una stupefacente
continuità. Nella novella Ming (XIV-XVII secolo)
si può ancora riconoscere in lontananza il suo modello del periodo
Tang (VII-X secolo). I
dipinti di paesaggi di un pittore Qing (XVII-XX secolo) in fondo sono costruiti in modo simile a
quelli della dinastia Song (X-XIII secolo).
Una ragione di ciò è il "rispetto per la tradizione" da sempre
diffuso in Cina.
Obiettivo primario dell'artista era non la creazione del nuovo, bensì
l'imitazione, il più possibile fedele all'originale, dei modelli degli antichi
– che del resto non è percepita in alcun modo come plagio o alternativamente
come disonesta. Questa visione si basa in fin dei conti sulla concezione del
mondo confuciana, che impone tra l'altro al discepolo la
venerazione del maestro.
Ma anche le altre dottrine religiose e filosofiche diffuse in Cina acquistarono in
continuazione rilevante influenza sulla produzione artistica. Né la pittura
cinese né le poesie dei poeti Tang sarebbero ad esempio immaginabili senza il Taoismo. Già dal
punto di vista tematico esse trattavano frequentemente del postulato di una
vita in armonia con la
natura. Ma anche la tecnica pittorica rivela influenze della dottrina
taoista dell'Ying e Yang, ad esempio
nell'alternanza dialettica tra superfici dipinte e vuote, o nel contrasto tra
pennellate "umide" e "asciutte". Oltre a ciò, naturalmente,
nelle opere dell'arte cinese compaiono in continuazione anche figure della
mitologia taoista. Più debolmente si esercitano nel frattempo le influenze del Buddhismo,
tanto più che questo nel corso del tempo fu comunque parzialmente sinizzato fino a divenire irriconoscibile. A partire dal XVI secolo,
inoltre, trasmessi in particolare attraverso l'attività dei missionari europei,
entrarono anche influssi occidentali.
I rappresentanti dell'arte cinese furono per motivi finanziari in massima
parte la corte imperiale, o meglio le cerchie dei cortigiani e degli eruditi.
Allo stesso tempo vi furono, soprattutto nella letteratura e nella pittura,
anche personalità artistiche isolate, che produssero le loro opere lontano
dalla gente in zone rurali, in valli montane o simili. Ma per lo più si tratta
in questo caso di eruditi o perfino di ex funzionari, che avevano voltato le
spalle al mondo per la frustrazione o l'indignazione per le condizioni
politiche dominanti. Una crescita di questo movimento si poté osservare
solitamente dopo i cambiamenti dinastici, in modo particolare quando, a metà
del XVII
secolo, avevano preso il potere i dominatori stranieri manciù (dinastia
Qing).
Effetti di diffusione dell'arte cinese si possono osservare in tutto lo
spazio est-asiatico. Essi sono naturalmente particolarmente evidenti in regioni
che furono un tempo sotto il dominio cinese, come gli "stati
vassalli" della Corea
e del Vietnam,
o che dai Cinesi furono colonizzate (Singapore, Malaysia, Indonesia).
Ma anche l'arte giapponese sotto questo aspetto deve
moltissimo al Regno di Mezzo. In alcuni settori specializzati gli epigoni
riuscirono perfino a superare il loro modello, come ad esempio nell'arte della lacca, arrivata in
Giappone ad altissime vette. A partire dal XVI secolo le opere d'arte cinesi –
specialmente anche la ceramica
– furono per la maggior parte esportate in Europa, dove acquistarono influenza
sull'arte occidentale.
L'arte di Taiwan
così come quella degli emigranti cinesi sono considerate come parte dell'arte
cinese, nella quale hanno le loro radici.
Sviluppo storico fino al 221 a.C.
Arte della ceramica neolitica
Le prime forme di arte cinese furono trovate nella neolitica cultura di Yangshao (仰韶文化), che risale al 5000 a.C.. Reperti archeologici come quelli di Banpo
hanno mostrato che già nel periodo di Yangshao veniva
praticata l'arte
della ceramica; i primi manufatti in ceramica spesso
non erano dipinti e presentavano frequentemente strutture plastiche cordate. Ai
primi elementi decorativi appartenevano pesci e visi umani,
che però alla fine si svilupparono in motivi astratti simmetrico-geometrici
, molti dei quali dipinti.
Il segno
caratteristico più spiccato della cultura di Yangshao
era l'uso estensivo di ceramiche dipinte, soprattutto con visi umani,
rappresentazioni di animali e motivi geometrici. A differenza della più tarda cultura di Longshan,
la cultura di Yangshao non conosceva ancora il tornio da vasaio. Secondo le scoperte
degli archeologi la società di Yangshao si basava su clan ad organizzazione matriarcale. Gli scavi hanno mostrato che
i bambini venivano sepolti in vasi di ceramica dipinti.
La cultura
della giada di Liangzhu
fu l'ultima cultura neolitica della giada nel Delta del Chang Jiang e durò circa 1.300 anni. L'arte
della giada di questo periodo coniò grandi vasi rituali finemente lavorati,
come ad esempio cong, bi, asce yue, come
pure ciondoli e amuleti sotto forma di uccelli, testuggini o pesci finemente cesellati. La giada di Liangzhu si distingue per il suo colore bianco lattiginoso,
che si fa risalire alla loro origine tremolitica.

Vaso rituale
della dinastia Shang
L'età del bronzo ebbe inizio in Cina con la dinastia Shang,
che è nota per la sua arte del bronzo ricca di dettagli. I fabbri dell'epoca
lavoravano abitualmente in officine fuori della città e vi fabbricavano
soprattutto vasi rituali nonché borchie per carri. I vasi di bronzo servivano
per contenere i liquidi più disparati, che venivano impiegati nelle cerimonie
religiose. Belli da vedere sono i vasi ku e jue, ma più impressionante appare il ding, una
brocca a tre piedi.
Sui vasi del periodo Shang
l'intera superficie disponibile veniva tipicamente rivestita di decori, spesso
di forme stilizzate di animali immaginari o realmente esistenti. Il motivo più
diffuso è il taotie,
una creatura fantastica rappresentata con una forma piatta e simmetrica.
Secondo un'interpretazione, deve trattarsi di un uomo lascivo che è stato
condannato per punizione a difendere i quattro angoli del cielo contro i mostri
maligni. Secondo un'altra opinione il taotie è
un mostro che è costituito solo da una testa e perciò nei suoi tentativi di
divorare gli uomini ferisce solo sé stesso.
Nel passaggio
dalla dinastia Shang a
quella Zhou mutarono
gradualmente forma e funzione dei bronzi. D'ora in poi essi servirono in misura
più massiccia per scopi profani. Nel periodo dei Regni Combattenti i vasi di
bronzo divennero persino oggetto di piacere estetico: comparivano
frequentemente scene di banchetti e di caccia, mentre altri mostravano motivi
astratti con inserti d'oro e d'argento nonché pietre preziose. Furono prodotti anche specchi di bronzo maggiormente levigati.
Grande
apprezzamento ebbero successivamente nella dinastia Song i
bronzi del periodo Shang. Tale apprezzamento era
dovuto non solo alla loro forma e configurazione, ma anche alla patina verde, azzurra e talvolta perfino
rossa, che avevano sviluppato a causa di processi chimici mentre erano sepolti. Lo studio dell'arte
dei primi bronzi cinesi è un settore specialistico della storia dell'arte.
Le origini dell'arte della musica e
della poesia cinesi potrebbero trovarsi nel Libro dei canti (詩經, Shījīng).
L'opera, composta fra il 1000 e il 600 a.C., contiene melodie popolari, canti
religiosi solenni ed inni di stato, ma anche canzoni d'amore, di guerra, di
digiuno e di lamento di tutti i tipi. Soprattutto le canzoni d'amore seducono
per la freschezza ed il candore della loro lingua.

Campana di
bronzo, dinastia Zhou
La prima
musica cinese si basava soprattutto su strumenti a percussione come la campana di bronzo, che veniva fatta
suonare dall'esterno con un battaglio; spesso intere file di campane venivano
appese su telai di legno. All'interno delle campane furono trovate tracce di
raschiature e levigature che presumibilmente sono da attribuire alla
"voce" della campana. Nel periodo dei Regni Combattenti agli
strumenti a percussione subentrarono gradualmente gli strumenti ad arco e a
fiato (zampogne).
Significativamente il secondo carattere della parola musica
(音乐; yīnyuè) è scritto allo stesso modo di gioia
(快乐; kuàilè). Confucio (孔子; C.). I canti di questa raccolta
sono svolti in un tono lirico e romantico e rappresentano quindi rispetto allo Shījīng un'altra tradizione dell'arte
della poesia cinese

Esercito di
terracotta di Xi'an
Malgrado la
sua brevità la Dinastia Qin, ampiamente identica al periodo di
governo del primo imperatore Qin Shihuangdi, si
colloca saldamente nella storia dell'arte cinese.
La ragione di
ciò è l'esercito di terracotta ritrovato nel
mausoleo dell'imperatore in costruzione nei pressi di Xi'an, famosissimo
e annoverato nel patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO. È costituito da più
di 7.000 figure di guerrieri e di cavalli a grandezza naturale in terracotta, che furono sepolte insieme a Shihuangdi. La colorazione originale delle figure dipinte
era ancora visibile al momento del loro disseppellimento, ma nel frattempo si è
cancellata a causa dell'aria, cosicché le figure appaiono nella semplice
tonalità terracotta. Esse furono raffigurate in una molteplicità di pose: sono
rappresentati sia soldati di fanteria in piedi che arcieri inginocchiati o
conducenti di carri, ma sono presenti anche generali. I volti e le acconciature
furono realizzati individualmente. Le figure spezzate sono state ricomposte a
mano, il che, in considerazione della massa dei frammenti, ha significato un
grande dispendio di tempo. Del resto per il momento è difficile che vengano
ancora disseppelliti soldati, per evitare la perdita di colore, dato che non è
ancora stata trovata una soluzione soddisfacente. La tinta, che ha resistito
sotto terra per molti secoli, a contatto con l'ossigeno sbiadisce.
Nell'epoca Qin ebbe luogo anche la fondazione dell'ufficio musicale
imperiale (vedi anche Yue fu).
Il Buddhismo giunse in Cina nel I secolo d.C., anche se secondo la
tradizione già al tempo del re Ashoka un
monaco avrebbe visitato il Regno di Mezzo. Fino all'VIII
secolo esso manifestò grande attività nel campo dell'arte, in particolare
nell'ambito della grande scultura religiosa. Ma ben presto l'arte buddhista
assorbì anche tratti cinesi autoctoni. Le Grotte di Yungang,
le Grotte di Mogao
e le Grotte di Longmen
offrono una ricca testimonianza dell'arte buddhista in Cina.
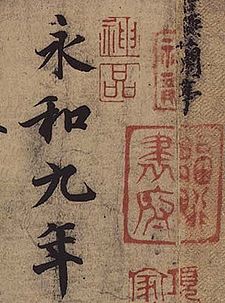
Calligrafia
di Wang Xizhi (IV
sec.) – Inizio del celebre poema sul Padiglione delle orchidee
Nei circoli di corte dell'antica Cina la pittura e la calligrafia erano considerate le arti più
altamente apprezzate. Venivano praticate soprattutto da dilettanti,
aristocratici e funzionari eruditi, che erano i soli a disporre del tempo
libero necessario per il il perfezionamento della
loro tecnica del pennello. La calligrafia era ritenuta la più alta e matura
forma espressiva della pittura. Si dipingeva con un pennello a spazzola
costituito da peli di animale ed un inchiostro di china fatto a base di nero
fumo e colla animale, inizialmente sulla seta, in seguito dopo l'invenzione della carta nel I secolo anche su questo materiale nuovo e
a buon mercato.
Le opere
originali di celebri calligrafi furono apprezzatissime
in Cina in tutti i tempi, stese su rotoli e talvolta appese al muro a guisa di
quadri.
 Buddha
Buddha
In
collegamento con una tendenza già inaugurata sotto la dinastia Sui, la grande scultura buddhista
si sviluppò anche sotto la dinastia Tang
aggiungendo un'espressione più realistica e naturale. In seguito all'apertura
al mondo esterno del Regno Tang e in particolare ai
suoi scambi culturali con lo spazio culturale indiano, le sculture buddhiste del periodo
Tang assorbirono una forma piuttosto classica,
influenzata dall'arte indiana Gupta.
L'arte
buddhista conobbe un crollo verso la fine del periodo Tang,
quando l'imperatore Wu Zong
nell'845 proibì tutte le religioni straniere, per ricollocare il Taoismo autoctono nella sua antica
posizione. Egli confiscò le proprietà buddhiste e costrinse i fedeli in
clandestinità, dopo di che anche l'arte andò ampiamente in decadenza.
Mentre la
maggior parte delle sculture lignee del periodo Tang
non sono sopravvissute alle persecuzioni, la produzione artistica in pietra si
è conservata in misura notevolmente maggiore. Le sculture più imponenti si
trovano a Longmen, a
sud di Luoyang
(provincia di Henan).
L'arte del
periodo Tang è associata soprattutto a sculture in
ceramica allo stato naturale o con smalti a colori, che rappresentano per lo
più cavalli, cammelli e demoni furenti (i "guardiani
dell'inferno"), ma anche dame di corte e musicanti. I tratti dei volti dei
personaggi rappresentati, talora evidentemente non cinesi, sono da spiegare
attraverso le influenze dell'Asia occidentale e dell'Europa, che venivano
trasmesse mediante il vivace commercio lungo la Via della Seta.
Risalgono
fino al periodo Tang anche le origini della porcellana inventata in Cina e
perfezionata sempre di più nel corso delle dinastie successive, che è prodotta
da una pasta costituita di caolino e feldspato. Rispetto alle ceramiche
tradizionali la porcellana già per le caratteristiche di lavorazione pone i
suoi creatori davanti a sfide notevolmente maggiori. Il più celebre luogo di
produzione è Jingdezhen
nella provincia dello Jiangxi, che
cambiò più volte nome nel corso della storia.
Durante la dinastia Sui ha avuto
inizio anche l'arte della xilografia cinese. Questa si praticava in particolare
per illustrare opere religiose e stampare sūtra buddhisti. La più antica xilografia a
stampa ancora conservata è considerata l'illustrazione del frontespizio del sutra Vajracchedikâ Prajna Paramitâ,
che data all'868 e fu scoperta nel 1907 a Dunhuang da Aruel Stein.
Le influenze
provenienti dall'estero da registrare durante il periodo Tang
riguardano anche la musica: soprattutto dall'Asia centrale furono ad esempio adottati
diversi nuovi strumenti musicali, in particolare liuti, cetre e violini. Il guqin,
noto già dalla dinastia Han, conobbe un periodo di prosperità. Seguì anche un
vivace ricambio di musicisti. Nel periodo Tang anche
la musica secolare si emancipò finalmente dalle radici religioso-cultuali ed acquisì
autonomo significato.
Nella dinastia Song
raggiunse l'apice soprattutto la pittura cinese. I paesaggisti ad esempio acquistarono
un'espressione più raffinata. Così a titolo di esempio l'immensità delle
distanze spaziali fu accennata mediante contorni sfuocati, profili di montagne
che sparivano nella nebbia o un trattamento quasi impressionistisco
dei fenomeni naturali.

Un soggetto
centrale della pittura Song erano anche
raffigurazioni di animali e piante. Grande ammirazione riscosse ad esempio il
suggestivo dipinto Lepre e ghiandaia di Cuī Bái
(Ts’ui Po, 崔白, attivo 1068–1077), ma anche le
creazioni dell'imperatore Huī Zōng (徽宗; 1082–1135), artisticamente dotato,
del quale sono tra gli altri i Due fringuelli su steli di bambù. Altri
rinomati pittori di animali e piante furono Mao I e Wén Tóng (文同; 1018–1079). Un'altra tendenza della
pittura Song adottò infine temi buddhisti e, ad esempio, rappresentò
spesso adepti del Buddhismo Chan.
Nel periodo Song raggiunse una prima prosperità la tecnica della lacca, già nota dalla dinastia Shang,
che trovò in particolare applicazione per i vasi. Accanto a lavori
monocromatici poté affermarsi anche la cosiddetta tecnica della lacca a fessura.
Dopo che si era inciso il decoro nello strato di lacca superficiale, si
sfregavano le cavità con oro e argento, mediante i quali si ottenevano
particolari effetti ottici.
Nel periodo Song conobbero parimenti il culmine i tappeti cinesi, che
ormai erano fabbricati quasi esclusivamente con il lino. Da un lato erano
richiesti motivi floreali con piante, fiori, uccelli ed insetti, ma anche scene
di paesaggi e rappresentazioni di uomini prese dalla vita di tutti giorni.
Già nella dinastia
Yuan la porcellana, allora nota in Cina già da
secoli, si era conquistata una posizione particolare nei confronti di altri
tipi di ceramica quali soprattutto il celadon. Nel periodo Ming però l'arte
cinese della porcellana raggiunse un primo culmine. Si affermò il cosiddetto stile bianco-azzurro: il colore azzurro
era ottenuto in questo caso dall'alluminato di cobalto CoAl2O4).
La porcellana manteneva il suo particolare splendore grazie alla vetrinatura
finale applicata sulla pittura.
Accanto a
motivi floreali-ornamentali prevalevano soprattutto
rappresentazioni di animali. Le tecniche di produzione furono continuamente
perfezionate. A Jingdezhen,
"capitale" della porcellana cinese già a partire dal periodo Tang, sorsero numerose nuove manifatture. Per la prima
volta la porcellana fu anche esportata in Europa su navi portoghesi, dove trovò rapido smercio
presso le corti principesche.
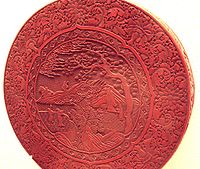
Nel periodo
Ming raggiunse un alto livello anche l'arte della lacca cinese. La lacca a
fessura della dinastia Song fu soppiantata in misura
crescente dalla cosiddetta lacca ad intaglio. Dalla lacca applicata in
molteplici strati soprattutto su vasi, venivano intagliati modelli geometrici,
floreali od ornamentali. Talvolta nascevano anche pretenziose rappresentazioni
sceniche.
Nei colori dominavano le lacche rosse
e nere; particolari effetti si raggiungevano mediante la combinazione di
entrambi i colori nei diversi strati.
 Raffigurazione di Xu Bao, 1810
Raffigurazione di Xu Bao, 1810
Anche la dinastia Qing ha
prodotto numerose importanti opere in prosa. In particolare trovò diffuzione il romanzo cinese classico. Il più celebre
rappresentante di questo genere, Il sogno della camera rossa (红楼梦 Hóng Lóu Mèng) di Cáo Xuěqín (曹雪芹; 1719–1763),
fu composto verso la metà del XVIII secolo. Una satira sul sistema dei
funzionari e degli esami imperiali dell'epoca è rappresentata
dal romanzo di Wu Jingzi La storia non ufficiale della foresta dei letterati
del 1749.
Yuan Mei creò
la maggior parte delle sue numerose poesie, saggi e ritratti negli ultimi dieci
anni della sua vita. La sua opera riflette l'interesse degli Yuan per il Buddhismo Zen ed il soprannaturale. Egli
divenne famoso soprattutto per le sue poesie, celebrate come
"insolitamente chiare e stilisticamente eleganti". Nella sua opera
teorica sull'arte della poesia, il Suíyáan shīhuà (隨園詩話), mise in
risalto l'importanza del sentimento personale come pure della perfezione
tecnica.
La forma
operistica cinese senza dubbio più celebre è l'Opera di Pechino. Anche se essa assunse la
sua forma attuale solo nel XIX secolo, era già manifestamente
popolare nel periodo Qing.
L'intreccio, perlopiù molto ricco di allusioni, vive della sua mimica e
gestualità fortemente coreografate. All'accompagnamento ritmico provvedono
tradizionali strumenti a corda e a percussione cinesi.
Nonostante il
suo nome l'Opera di Pechino ha le sue origini piuttosto nelle tradizioni
operistiche locali, in particolare delle province di Anhui e Hubei, dalle
quali provengono non solo due popolari melodie di grande importanza (Xipi ed Erhuang),
ma anche la lingua arcaica impiegata nell'Opera di Pechino. Ma si possono
provare influenze anche da parte della musica di Qinqiang.
Come momento di nascita dell'Opera di Pechino si considera una rappresentazione
di compagnie teatrali provenienti da Anhui in
occasione del 60º compleanno dell'imperatore Qianlong nel
1790. Una scena collettiva con attori di Hubei nel
1828 portò l'Opera di Pechino nella forma essenzialmente ancora oggi vigente.

All'inizio
della dinastia Qing si
erano definitivamente imposti i pittori letterati; i pittori di professione al
contrario non giocavano più quasi alcun ruolo.
Sono da
distinguere essenzialmente tre scuole: la cosiddetta scuola ortodossa vincolata a modelli
tradizionali costruiva i suoi dipinti meticolosamente, linea per linea e
tonalità per tonalità, evitando linee più sicure, ininterrotte e superfici
semplici. Si rinunciava in gran parte anche agli artifici tecnici e al
conseguimento di effetti speciali. Uno stile stile
più libero praticava invece la scuola individualistica. I suoi
esponenti lavoravano frequentemente con forme sciolte, incorporee così come con
effetti di luce ed ombra e crearono così, tra l'altro, dipinti di paesaggi molto
suggestivi e animati. Per gli stili di pittura e di vita addirittura bizzarri
si fecero notare da ultimo i cosiddetti Otto Eccentrici di Yangzhou,
sopraggiunti in seguito. Gāo Qípeì (高其佩; 1660–1734)
ad esempio era solito dipingere i suoi quadri con le mani, le dita e le unghie.
Come caso particolare infine si aggiunge ancora la pittura dei missionari gesuiti presso la corte Qing.
Celebri
esponenti della pittura Qing sono Wáng Shímǐn
(王時敏; 1592–1680),
Wú Lì (吴历; 1632–1718), Shí Tāo (石濤; anche Daoji;
1642–1707) e Luó Pìn (羅聘; 1733–1799). Il principale pittore
europeo in Cina fu Giuseppe Castiglione.
 Piatto in stile famiglia rosa
Piatto in stile famiglia rosa
L'arte della porcellana cinese fiorita
nel periodo Ming ebbe un ulteriore sviluppo sotto i Qing.
Al disegno bianco-azzurro di impronta ornamentale un tempo dominante, successe
d'ora in avanti un decoro colorato con rappresentazioni particolareggiate,
ricche di figure. Ad esempio erano in voga scene della vita di corte o in
campagna, rappresentazioni di romanzi classici o scene mitologiche. Si
distinguono in particolare la famiglia verde e la famiglia rosa, denominate in base al
loro colore predominante. Oltre a ciò vi era per contrasto la porcellana Dehua,
puramente bianca, spesso utilizzata per sculture, che in Europa è chiamata
spesso "blanc de Chine". Essa assumeva il
suo colore intensamente luminoso mediante l'aggiunta di una notevole quantità
di feldspato.
L'arte della porcellana Qing raggiunse un culmine sotto gli imperatori Kangxi, Yongzheng e Qianlong, che
esportarono la merce in grande stile in particolare in Europa. A tale riguardo
una certa diminuzione fu da registrare dopo che, nel 1709, alla corte di Augusto il Forte a Dresda riuscì per la prima volta la
fabbricazione di porcellana in Europa.
Nella
dinastia Qing con la lacca si rivestirono non più solo vasi,
cassettine e simili, bensì d'ora in avanti anche mobili e soprattutto
paraventi.
Per la prima volta nacque anche la
cosiddetta tecnica della lacca di Coromandel:
su fondo dipinto a colori venivano poi applicati parecchi strati di lacca. Dopo
la completa asciugatura si intagliavano nella lacca disegni in filigrana, così
che le superfici colorate sottostanti - spesso separate solo da barriere
sottili come un capello - fossero in parte nuovamente visibili. In questo modo
in parte nacquero lavori spiccatamente pretenziosi. Nel Linden-Museum
a Stoccarda ad esempio si può vedere un paravento, che narra dettagliatamente
della vita e delle opere degli Immortali taoisti.
Parimenti
grande popolarità godette l'arte della lacca di madreperla, nella quale si
introducevano nella lacca disegni e figure in filigrana fatti di madreperla. Un celebre esempio a tal fine
è il sontuoso trono da viaggio dell'imperatore Kang Xi nel Museum für Asiatische
Kunst a Berlino.
In particolare a causa delle influenze europee, la
letteratura cinese dopo la caduta dell monarchia
ereditaria conobbe nuovi impulsi. Pietre miliari al riguardo furono poste dal
manifesto di Hu Shi del 1916
come pure dal cosiddetto Movimento del 4 maggio, che avevano
entrambi abbracciato la causa del superamento del confucianesimo tradizionale e
di una modernizzazione della cultura cinese.
Dopo il crollo della dinastia Qing
nella pittura cinese ebbe luogo una differenziazione fino ad allora non
conosciuta. Molti artisti sotto molteplici influenze poltiiche
e cultuali si staccarono dai modelli tradizionali e svilupparono stili estremamemte individuali.
I quadri di Qí Báishí (齐白石; 1864–1957)
si caratterizzano per strutture semplici e pennellate veloci, abili. Tra i suoi
soggetti preferiti si annoverano scenari campestri, attrezzi agricoli, ma
soprattutto raffigurazioni di animali e di piante particolarmente efficaci dal
punto di vista realistico.
Xú Bēihóng
(徐悲鸿; 1895–1953)
importò tecniche europee nella pittura cinese; è divenuto famoso ad esempio
come pittore di cavalli al galoppo. Negli anni 1930
realizzò influenti dipinti come Tian Heng e i cinquecento ribelli, Jiu
Fanggao e Pioggia primaverile sul fiume Lijiang. Alle moderne opere dell'arte europea si
orientò Lín Fēng Mián
(林風眠; 1900–1991),
a lungo bandito dalla politica culturale ufficiale. Colori sgargianti, forme
appariscenti e ricchi contenuti improntano la sua opera.
Parimenti esportata fu l'arte della lacca cinese, sebbene in
questo caso in generale si desse preferenza ai prodotti del Giappone. Al tempo
della grande esportazione d'arte, infatti, il Regno delle Isole con il suo
modello aveva da tempo superato la Cina in questo campo. Di grande
considerazione godevano da un lato i mobili in lacca con dispendiose pitture e
incrostazioni. Dall'altro si era soliti pannellare volentieri i gabinetti
d'arte principeschi con elementi di paraventi smontati. Come collezionisti di
lacche furono attivi tra gli altri il principe Federico Guglielmo di Brandeburgo nonché
il re Carlo II d'Inghilterra; entrambi erano
entrati in contatto per la prima volta con l'arte cinese durante dei soggiorni
di studio in Olanda.
Un terzo bene d'esportazione che veniva richiesto
erano i tappeti cinesi, che in particolare
erano trasportati per nave verso Amsterdam e Londra e da lì distribuiti alle
corti principesche europee. In seguito vennero imitati, in primo luogo nel
quadro della moda delle cineserie, prima di diventare infine il punto di
partenza di una propria, autonoma cultura dei tappeti europea.
La ricezione della letteratura cinese si fece attendere
invece addirittura fino al 1900 circa. Per l'Italia, a parte le prime
traduzioni dei testi classici confuciani a cura dei gesuiti Michele Ruggieri
e Prospero Intorcetta
nei secoli XVI e XVII, il primo incontro con la letteratura cinese si ebbe nel
1883 con Il dente di Budda, traduzione di Alfonso Andreozzi
del grande romanzo Shuihu zhuan. Le liriche cinesi, attraverso l'adattamento
francese del Livre de Jade
(Parigi, 1867) di Judith Walter, ispirarono a Tullo Massarani il suo Libro
di giada (1882) e ad altri letterati numerose fortunate antologie. Ancora
oggi fondamentale per la conoscenza della cultura cinese fu poi il saggio di
Guido Amedeo Vitale, Pekinese rhymes, (Pechino, 1896).
Nel XX secolo la conoscenza della
cultura e della letteratura cinese si diffuse in tutta Europa, esercitando
talora anche un'importante influenza su alcuni autori. Tra gli scrittori di
lingua inglese, ad esempio, fu in particolare Ezra Pound a
riprendere il metodo della lirica cinese. Un'ampia accoglienza ebbe anche La
montagna di giada (1929) di Witter Bynner, un
adattamento soprattutto di poesie della dinastia Tang.
In Italia, un
contributo particolare alla conoscenza della Cina e della sua cultura venne
anche dai libri di viaggio. Basti citare, per tutti, il racconto del viaggio
del 1907 di Luigi Barzini e Scipione Borghese da Pechino a Parigi in
automobile, e i resoconti di letterati e giornalisti tra gli anni '20 e '30,
fino ad arrivare, negli anni '50, alla Cina divenuta Repubblica Popolare
Cinese, di cui pure esistono importanti e significative testimonianze ad opera
di giornalisti ed intellettuali italiani.
Proprio a partire dagli anni '50, le traduzioni, sempre
più spesso direttamente dal cinese, hanno ampliato il loro ambito, abbracciando
poesia, narrativa, saggistica e mettendo in luce l’opera di sinologi
e traduttori di valore, Martin Benedikter per la poesia Tang,
Renata Pisu, Primerose Gigliesi, Edoarda Masi per la
narrativa e la saggistica.[1]
 Raffigurazione di Xu Bao, 1810
Raffigurazione di Xu Bao, 1810