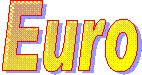
|
Moneta da un euro |
|
|
EUR |
|
|
|
|
|
16
|
|
|
€ |
|
|
100 centesimi |
|
|
In circolazione dal: |
|
|
|
|
|
Tasso
di cambio: |
1 EUR = 1,3659 US$ |
|
|
|
|
|
|
La pagina di discussione contiene dei suggerimenti per migliorare la voce

L'euro (EUR o €) è la valuta comune ufficiale dell'Unione europea (nel suo insieme) e quella unica per sedici stati membri che attualmente aderiscono all'UEM (Unione economica e monetaria), ovvero Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna.[1] Il prossimo paese ad adottare l'euro sarà l'Estonia nel 2011. Il complesso di questi paesi, detto informalmente Eurozona, conta oltre 320 milioni di abitanti; prendendo in considerazione anche quei paesi terzi che utilizzano divise legate all'euro, la moneta unica interessa direttamente oltre 480 milioni di persone in tutto il mondo.
Undici dei 27 stati membri dell'Unione europea non adottano tuttavia l'euro come valuta ufficiale. Nella fattispecie, la Danimarca[2] e il Regno Unito[3] godono di una clausola che permette loro di mantenere indefinitamente le proprie valute nazionali; anche la Svezia, che fa parte dell'UE dal 1995, sta continuando ad usare la corona svedese.
Nei rimanenti otto paesi, l'introduzione della divisa comune sarà possibile non appena le condizioni macroeconomiche permetteranno di garantire il rispetto dei parametri di Maastricht.
In aggiunta ai membri dell'Unione, alcuni microstati (Città del Vaticano,[4] il Principato di Monaco,[5] San Marino[6] e Andorra[7]), hanno adottato l'euro in virtù delle preesistenti condizioni di unione monetaria con paesi membri della UE.
Infine il Montenegro e la regione indipendentista serba a maggioranza albanese del Kosovo hanno adottato unilateralmente l'euro.
Il debutto dell'euro sui mercati finanziari risale al 1999, mentre la circolazione monetaria ha effettivamente avuto inizio il 1º gennaio 2002 nei dodici paesi dell'Unione che per primi hanno adottato la nuova valuta.
L'euro è amministrato dalla Banca centrale europea, con sede a Francoforte sul Meno, e dal Sistema europeo delle banche centrali; il primo organismo è responsabile unico delle politiche monetarie comuni, mentre coopera con il secondo per quanto riguarda il conio e la distribuzione di banconote e monete negli stati membri.
L'euro è suddiviso in 100 centesimi.
Nome e simbolo
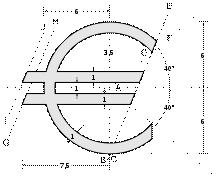
Le specifiche del logo che rappresenta il simbolo dell'euro.
Il nome euro deriva dalle lettere iniziali della parola Europa, ed è stato adottato dal Consiglio europeo di Madrid del 1995 per rimpiazzare la sigla ECU (dall'acronimo inglese European Currency Unit, o "Unità di conto europea"), sino a quel momento utilizzata nei trattati. Il nome doveva essere semplice, unico e invariabile.[8] Molti paesi hanno deciso di usare normalmente il plurale o il partitivo del nome,[9] anche se sulla cartamoneta il sostantivo "euro", chiaramente mostri che il sostantivo non dovrebbe conoscere plurale.
La denominazione ecu, indicata nell'articolo 3a del trattato di Maastricht, fu scartata per diverse ragioni linguistiche. Aveva un senso in inglese, la lingua nella quale era espresso, e in francese, perché la parola écu vuol dire scudo, che era un'antica moneta della Francia. La denominazione, quindi, non aveva alcun richiamo per gli altri paesi. Ci fu poi il "problema della vacca tedesca": i tedeschi avrebbero dovuto chiamare un ecu ein Ecu, che suonava come eine Kuh, cioè, appunto, una mucca.
Il codice internazionale a tre lettere (in base allo standard ISO 4217) dell'euro è EUR. È stato disegnato anche un simbolo (glifo) speciale per l'euro (€). Dopo che un sondaggio pubblico aveva ristretto la scelta a due, fu la Commissione europea a fare la scelta finale. Il vincitore era ispirato dalla lettera greca epsilon (ε), così come a una versione stilizzata della lettera "E".
L'euro è rappresentato nel set di caratteri Unicode (esadecimale 20AC o decimale 8364, codice mnemonico HTML: €) così come nelle versioni aggiornate dei tradizionali set di caratteri latini. Le nazioni occidentali dovrebbero passare dall'ISO 8859-1 (Latin 1) all'ISO 8859-15 (Latin 9) o, ancora meglio, a UTF-8 per poter rappresentare questo carattere.
Il "nome unico" ha in realtà due varianti: la prima riguarda la lingua greca, la seconda la lingua bulgara. La Grecia ottenne subito di poter chiamare la moneta unica Ευρώ in caratteri ellenici. La Bulgaria ottenne durante le negoziazioni per il Trattato di Lisbona di chiamare la moneta unica Евро, in caratteri cirillici[10].
E' interessante comunque notare come sulle banconote a fianco del nome della moneta in caratteri occidentali venga riportata unicamente la scrittura in alfabeto greco, ossia ΕΥΡΩ che è simile ma differisce per l'ultima lettera con la scrittura in alfabeto cirillico moderno (che non prevede la presenza della Ω), che infatti risulterebbe essere ΕΥΡO.
Monete e banconote
Monete
Dal 2002 sono in circolazione monete metalliche con otto diversi valori:
- monete da 1 cent, 2 cent e 5 cent, di colore rame, in acciaio ricoperto di rame;
- monete da 10 cent, 20 cent e 50 cent, di colore oro, in oro nordico;
- monete da 1 euro e 2 euro, bimetalliche, di colore argento/oro.
Ciascuna moneta è caratterizzata da un lato comune a tutti i paesi che hanno adottato l'euro; l'effigie sull'altro lato è di competenza esclusiva dei singoli stati, e pertanto sono attualmente in circolazione perlomeno 8×16=128 diverse monete, senza considerare le monete commemorative e quelle coniate da San Marino, Città del Vaticano e Principato di Monaco in virtù di accordi bilaterali con Italia e Francia.
La Finlandia ha deciso di non produrre e di non far circolare le monete da 1 e 2 centesimi, ad eccezione di piccole quantità per il collezionismo. Dal 2004 anche i Paesi Bassi[11] non immettono in circolazione monete da 1 e 2 centesimi; tuttavia quelle in circolazione, benché poco utilizzate, mantengono corso legale. Ciò nonostante, le monete di tale valore coniate in altri paesi continuano naturalmente ad avere valore legale all'interno di tutta l'Eurozona.
|
L’Europa nel mondo |
L’Europa come un'alleanza di Stati |
L’Europa senza frontiere |
|||||
Banconote
Le banconote euro, a differenza delle monete, sono caratterizzate da un aspetto unico valido in tutta la zona euro e sono disponibili in sette tagli, ognuno con colore e dimensione diverse: 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500 euro.
Ogni taglio presenta una particolare tematica architettonica e storica nel contesto europeo. Per ogni tematica, il fronte della banconota presenta delle porte e delle finestre, mentre il retro raffigura dei ponti.
Considerato gli elevati importi che le banconote rappresentano e la potenzialità dell'euro di poter essere utilizzata come valuta di riserva internazionale, nella fase di progettazione è stato deciso di applicare sofisticate tecnologie anti-contraffazione.
Attualmente ogni banca centrale dell'Unione monetaria europea è responsabile per la stampa di uno o due tagli.
|
Valori delle banconote |
|||||||
|
Taglia delle banconote |
120 mm x 62 mm |
127 mm x 67 mm |
133 mm x 72 mm |
140 mm x 77 mm |
147 mm x 82 mm |
153 mm x 82 mm |
160 mm x 82 mm |
|
Colore |
|||||||
|
Architettura |
|||||||
|
Periodo |
prima del V secolo |
||||||
|
Fronte |
|||||||
|
Retro |
Storia dell'introduzione dell'euro
Le fasi di transizione dalle monete locali all'euro vennero stabilite dalle disposizioni del Trattato di Maastricht del 1992 relative alla creazione dell'Unione economica e monetaria.
Per poter partecipare alla nuova valuta, gli stati membri dovevano rispettare i seguenti criteri, informalmente detti parametri di Maastricht:
- un deficit pari o inferiore al 3% del prodotto interno lordo;
- un rapporto debito/PIL inferiore al 60%;
- un tasso di inflazione non superiore di oltre 1,5 punti percentuali rispetto a quello medio dei tre stati membri a più bassa inflazione;
- tassi d'interesse a lungo termine non superiori di oltre 2 punti percentuali rispetto alla media dei tre stati membri a più bassa inflazione;
- appartenenza per almeno un biennio al Sistema monetario europeo.
In fase di accettazione, vennero compresi anche gli stati membri i cui parametri avevano dimostrato la tendenza a poter rientrare nel medio periodo all'interno dei criteri stabiliti dal Trattato. In particolare, all'Italia e al Belgio fu permesso di adottare subito l'euro anche in presenza di un rapporto debito/PIL largamente superiore al 60%.
Fra i paesi che avevano chiesto l'adesione alla moneta unica sin dal suo esordio, la Grecia era l'unica che non rispettava nessuno dei criteri stabiliti; fu comunque ammessa due anni dopo, il 1º gennaio 2001, e l'introduzione fisica della nuova valuta nel paese avvenne contemporaneamente rispetto agli altri undici paesi.
I tassi di cambio tra le varie divise nazionali e l'euro furono determinati dal Consiglio europeo in base ai loro valori sul mercato al 31 dicembre 1998,[12] in modo che un ECU (European Currency Unit, Unità di valuta europea) fosse pari a un euro. Essi non furono stabiliti in una data precedente a causa della composizione particolare dell'ECU, il quale era una unità di conto che dipendeva da un paniere di valute comprendenti anche quelle che, come la sterlina inglese, non avrebbero fatto parte dell'euro.
In Italia l'euro venne sperimentato per la prima volta nei comuni di Fiesole e Pontassieve per mesi 6 a partire dall'1 ottobre 1999[13].
La zona euro
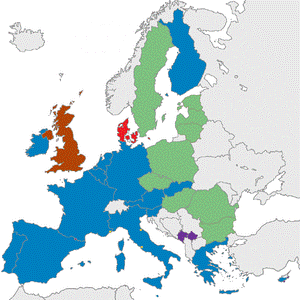
██ Zona euro
██ Paesi membri che, in virtù del Trattato di Maastricht, sono destinati a confluire nella zona euro
██ Paese membro che, in deroga al Trattato di Maastricht, si riserva di stabilire un eventuale ingresso nella zona euro
██ Paese membro che, in deroga al Trattato di Maastricht, si riserva di stabilire un eventuale ingresso nella zona euro tramite un prossimo referendum
██ Paesi extra-UE che adottano l'euro in virtù di accordi bilaterali con la Banca Centrale Europea
██ Paesi e territori extra-UE che adottano unilateralmente l'euro
Al momento gli stati membri che partecipano all'euro sono 16: l'insieme di queste nazioni viene frequentemente definito "Eurozona", o "Eurolandia". L'ultimo stato in ordine cronologico ad aderire alla valuta comune è stata la Slovacchia, il 1º gennaio 2009.
|
Stati |
Adozione dell'euro |
Dei rimanenti paesi membri dell'Unione Europea, Regno Unito e Danimarca (in seguito ad un referendum) possiedono una speciale deroga al trattato di Maastricht che li esime dall'obbligo formale di aderire alla divisa comune; il Paese scandinavo ha annunciato il 22 novembre 2008 un referendum entro il 2010 per entrare nell'euro. Tutti gli altri, al contrario, sono destinati a confluire nella zona euro non appena i loro parametri macroeconomici lo consentiranno.
Allargamento della zona euro
L'euro è entrato in vigore per la prima volta il 1º gennaio 1999 in undici degli allora quindici stati membri dell'Unione[14][15]; a questi si aggiunse la Grecia, che rientrò nei parametri economici richiesti nel 2000[16][17] e fu ammessa nell'eurozona il 1º gennaio 2001. In questi primi dodici stati l'euro entrò ufficialmente in circolazione il 1º gennaio 2002 sotto forma di monete e banconote.
Nel 2006 un tredicesimo stato, la Slovenia, entrata nell'Unione nel 2004, dimostrò di possedere i parametri economici necessari per l'adesione alla divisa comune e fu ammessa nella zona euro il 1º gennaio 2007[18][19]. Pochi giorni dopo, il 15 gennaio, il tallero sloveno fu ufficialmente considerato fuori corso.
Con procedura analoga, nel 2007 Malta e Cipro, in virtù dei propri parametri macroeconomici soddisfacenti, vennero a loro volta ammessi nella zona euro[20][21][22][23]. L'introduzione della divisa comune nelle due isole mediterranee è avvenuta il 1º gennaio 2008.
Dal 1º gennaio 2009 il sedicesimo stato ad adottare come moneta l'euro è la Slovacchia [24].
Dal 1° gennaio 2011 anche in Estonia circolerà la moneta unica [25].
L'eurogruppo e la SEPA
La scultura luminosa raffigurante il glifo dell'euro posta di fronte al palazzo della Banca centrale europea, a Francoforte sul Meno.
Le questioni connesse strettamente all'unione economica e monetaria vengono discusse da un organismo apposito chiamato Eurogruppo, che si riunisce informalmente prima delle riunioni dell'Ecofin e a cui partecipano solo gli stati membri dell'Eurozona.
Recentemente è poi entrata in vigore l'Area unica dei pagamenti in euro, detta anche SEPA, iniziativa tesa ad armonizzare nell'area i bonifici, gli incassi e l'uso delle carte, rendendo sempre più efficiente, sicuro e conveniente il mercato elettronico.
Effetti della moneta unica
Dall'adozione di una moneta unica ci si aspetta un incremento dell'interdipendenza economica e una facilitazione del commercio tra Stati membri. Questo dovrebbe portare benefici a tutti i cittadini dell'Eurozona, in quanto l'incremento dei commerci è storicamente una delle forze guida della crescita economica. Inoltre la moneta unica si inserisce nel piano a lungo termine di un mercato unico all'interno dell'Unione.
Un secondo effetto dovrebbe essere una riduzione nelle differenze dei prezzi, ovvero un'uniformità dei prezzi in tutta l'Eurozona, che dovrebbe risultare in una maggiore competizione tra aziende, che dovrebbe aiutare a contenere l'inflazione e quindi essere a vantaggio dei consumatori. A quattro anni dall'introduzione il livellamento sembra però essersi orientato nell'aumento dei prezzi nei Paesi dove erano più bassi, piuttosto che con il calo dei prezzi nei paesi dove erano più alti. Altrettanto non è avvenuto per i salari.
In corrispondenza con l'introduzione di monete e banconote euro, in Italia molti hanno notato un notevole aumento dell'inflazione. I motivi addotti sono stati diversi:
- la scarsa e tardiva penetrazione dei supermercati che hanno concordato con il Governo la conversione dei prezzi esattamente secondo il cambio lira/euro e prezzi calmierati per molti prodotti, anche a causa dell'opposizione dei supermercati;[26]
- la mancanza di controlli, che erano oggettivamente difficili nella piccola distribuzione dove il prezzo è deciso da una miriade di negozi, piuttosto che centralmente per migliaia di punti vendita, come avviene nella GDO. A ciò si aggiunge che in un'economia di mercato lo Stato non può fissare i prezzi e l'interesse alla collusione, favorito dalla bassa concorrenza presente nei mercati europei della piccola distribuzione, ha portato i commercianti a praticare forme tacite di cartello, allineando i loro prezzi con quelli più alti presenti sulla piazza;
- la svalutazione della lira. Germania e Francia erano abituati all'utilizzo dei centesimi, e un franco (o un marco) erano una somma con la quale era ancora acquistabile qualche bene. L'unità base della nostra moneta, una lira, non veniva più coniata da anni e non consentiva di acquistare più nulla.
- la mancata rivalutazione della lira. Diversamente da Grecia e Germania (sotto Adenauer), l'Italia dopo le due guerre mondiali non rivalutò la propria moneta. [27]
- la politica di svalutazione della lira negli anni, che pur avendo dato frutti a breve termine, ha difatti indebolito la valuta italiana sul lungo termine, e che ha reso particolarmente svantaggioso il cambio lira/euro, il cui potere d'acquisto è lo specchio della reale salute economica del paese, con una valuta non più "drogata" dalla svalutazione monetaria e dalla politica del debito pubblico, limitato tra l'altro dai rigidi parametri di spesa della UE.
I dati 2001 confrontati con quelli 2002[28][29] mostrano però che un certo aumento c'è stato solo nella seconda metà dell'anno. Tra le possibili ipotesi per spiegare la differenza tra inflazione percepita e inflazione reale ci sono la distorsione del paniere ISTAT che sottostimava i consumi di tutti i giorni e la conversione "ad occhio" 1 euro = 2000 lire che è errata di più del 3%.
Alcuni economisti sono preoccupati dei possibili pericoli dell'adozione di una moneta unica in numerose aree diverse. Poiché l'Eurozona adotta un'unica politica monetaria, impostata dalla BCE, questa non può essere regolata per le situazioni economiche delle singole nazioni. Gli investimenti pubblici e le politiche fiscali di ogni nazione sono quindi l'unico modo in cui i cambiamenti economici possono essere introdotti specificamente per ogni regione o nazione.
Altri evidenziano che l'Eurozona è simile per dimensioni e popolazione agli Stati Uniti, che hanno una valuta unica e una politica monetaria impostata dalla Federal Reserve. Comunque, i singoli stati che compongono gli Stati Uniti hanno meno autonomia regionale e un'economia più omogenea delle nazioni dell'UE. Di particolare preoccupazione è il fatto che le economie dell'UE potrebbero non essere 'in sincronia', sia come ciclo economico che come pressione inflazionistica.
Si è detto che l'euro dovrebbe aggiungere grande liquidità ai mercati finanziari europei. Governi e compagnie possono prendere a prestito euro invece delle valute locali e questo si presume che permetterà l'accesso a più fonti di finaziamento. Altri economisti considerano che la forza potenziale di Eurolandia risiederà negli sforzi coerenti di una super-economia virtuale, nella quale sarà potenzialmente più facile creare forti associazioni finanziarie, piuttosto che una mera somma di singole liquidità.
Un ultimo e decisivo effetto è quello sul prezzo del petrolio. Eurolandia consuma più petrolio importato degli Stati Uniti. Questo significherebbe che più euro fluiranno verso le nazioni dell'OPEC, a parte il fatto che queste nazioni prezzano il petrolio solo in dollari (l'Iraq di Saddam Hussein era un'eccezione). Ci sono state frequenti discussioni nell'OPEC sulla prezzatura del petrolio in euro, che avrebbe vari effetti, tra i quali, costringere le nazioni a tenere riserve di euro per comprare petrolio, piuttosto che le riserve di dollari che hanno attualmente. Questo comporterebbe il trasferimento di un flottante che attualmente sussidia gli Stati Uniti e che andrebbe invece a sussidiare l'Unione europea.
Tassi di cambio dell'euro
Monete e banconote in euro. Nella foto si vedono monete di Germania, Belgio, Spagna, Finlandia e Lussemburgo.
Dopo l'introduzione dell'euro, il tasso di scambio con le altre valute, specialmente il dollaro, scese pesantemente. Alla sua introduzione nel 1999, l'euro era scambiato a $1,18. Da lì scese a fine 2000 fino a $0,85, per poi risalire all'inizio del 2001 fino a $0,95. Riprese a scendere fino al minimo storico sotto $0,84 nel luglio 2001. Alla luce degli scandali contabili delle aziende statunitensi (Enron, MCI Worldcom) le due valute raggiunsero la parità il 15 luglio 2002, e per la fine dello stesso anno l'euro raggiunse gli $1,04.
Si è speculato che la forza dell'euro rispetto al dollaro potrebbe incoraggiarne l'uso come valuta di riserva. Il 23 maggio 2003, l'euro sorpassò la quota iniziale di $1,18 e a dicembre 2004 arrivò a superare gli $1,36. Parte della forza dell'euro era dovuta ai tassi di interesse, che in quel periodo erano più alti in Europa rispetto agli Stati Uniti, e al deficit sempre crescente della bilancia commerciale statunitense. Nonostante la Federal Reserve abbia aumentato il tasso di sconto nel corso del 2005, per far fronte ad probabile rischio d'inflazione, il dollaro non è riuscito a migliorare il tasso di cambio con la moneta europea. Dal luglio del 2007 la crisi del mercato immobiliare statunitense ha ulteriormente indebolito la posizione della moneta americana che è giunta ad aver un tasso di cambio pari 1,37 $/€.[30]
A seguito della decisione intrapresa il 18 settembre 2007 dalla Federal Reserve di ridurre il tasso di sconto di 50 punti base allo scopo di affrontare la crisi di liquidità dovuta ai mutui subprime, il dollaro si è avviato su un percorso di lenta discesa del suo tasso di cambio. Come conseguenza di questa politica, ripetutasi nei mesi successivi, dalla seconda metà di settembre la moneta europea ha inanellato una serie di record storici nei confronti di quella statunitense, arrivando a toccare la quotazione di 1,60 $/€ il 15 luglio 2008[31].
A partire dall'inizio del 2008 l'euro ha intrapreso un sentiero di ascesa anche nei confronti della sterlina inglese che ha portato la valuta continentale a raggiungere diversi record storici, l'ultimo dei quali si è verificato il 30 dicembre 2008 a 0.9804 £/€.
A seguito della forte incertezza economica, nel mese di ottobre 2008, l'Euro è sceso sotto 1,50 US$, ma rimane comunque al di sopra di 1,25 US$.
La tassa, nell'ordinamento tributario italiano, si differenzia dall'imposta in quanto applicata secondo il principio della controprestazione, cioè essa è legata ad un pagamento di una somma di denaro, dovute da un soggetto quale corrispettivo per la prestazione a suo favore di un servizio offerto da parte di un ente pubblico (ad esempio: tasse portuali ed aeroportuali, concessioni, autorizzazioni, licenze...). Questo strumento tende a perdere importanza, nei moderni sistemi tributari, a favore di altri strumenti, quali la tariffa (vedi passaggio dalla TARSU alla TIA) o l'imposta.
La distinzione tra tassa e imposta è ereditata dal diritto romano ed è tipica dei Paesi di diritto latino. Nei Paesi di Common Law (Regno Unito e Stati Uniti) vige da tre secoli il principio del "no taxation without representation", ideato all'inizio della Rivoluzione americana. Si tratta di un principio in base al quale i cittadini che pagano i tributi devono essere rappresentati in Parlamento, e i tributi debbano derivare da una decisione parlamentare, in merito a un servizio di cui beneficiano i contribuenti.
Nei Paesi democratici esiste un dibattito
sulle modalità di prelievo e sull'impiego delle tasse. Le tasse servono a
ripagare il debito pubblico, finanziare servizi come scuole,
sanità, assistenza. alcuni Paesi hanno adottato un sistema di flat tax,
ad aliquota unica o con poche aliquote per le principali imposte. alcuni
ritengono che la semplificazione fiscale la riduzione delle aliquote riducano
elusione ed evasione, a l limite che in base alla curva
di Laffer un'aliquota unica, opportunamente scelta, massimizzi il gettito
fiscale. Altri ritengono l'aliquota unica e la riduzione degli scaglioni
profondamente iniqua verso i ceti medi e contro il principio di progressività
del prelievo fiscale, affermato in varie Costituzioni.
Altri propongono una Tobin tax un prelievo minimo sulle transazioni
finanziarie, che darebbe comunque un gettito enorme, visti i volumi di denaro
movimentati ogni giorno.
I servizi pubblici divisibili, quali ad esempio l'istruzione e la sanità, possono essere finanziati mediante tasse. Ne sono esempi in Italia, le tasse scolastiche e universitarie o i ticket sanitari. Tuttavia, non si deve confondere la tassa con il prezzo di questi servizi. Almeno nell'ordinamento attuale italiano le tasse non coprono completamente il costo di questi servizi, che quindi ricade sulla fiscalità generale e viene finanziato con le imposte. Le giustificazioni, provenienti dalla dottrina economica per tale scelta, sono diverse. In primo luogo essa si giustifica con la teoria delle esternalità, secondo cui il consumo di determinati servizi produce benefici indiretti, non solo al consumatore, ma all'intera società, giustificandone così il contributo alla copertura dei costi con la fiscalità generale. Per fare un esempio, l'istruzione universitaria produce benefici per lo studente ma anche per la società di cui viene accresciuto il livello culturale. In secondo luogo essa si richiama al principio costituzionale della capacità contributiva nel concorso a finanziare le spese pubbliche. Pertanto si ritiene necessario consentire la fruizione dei servizi ai meno abbienti fissando l'importo della tassa al di sotto del costo (o addirittura esentando alcune categorie dal pagamento) e contribuendo per la differenza con la fiscalità generale, che tiene conto di questo principio.
La questione se privilegiare il c.d. principio di capacità contributiva affidando il finanziamento dei servizi pubblici, anche divisibili, alle imposte con evidenti vantaggi in termini di redistribuzione della ricchezza, ma con lo svantaggio di svincolare il costo dei servizi stessi dal loro consumo, incoraggiando quindi fenomeni di free riding e di spreco o passare invece, ove possibile, ad una stretta applicazione del principio della controprestazione, accantonando così in parte l'idea redistributiva con una penalizzazione nell'accesso ai servizi dei meno abbienti ma con un maggiore controllo sul loro corretto utilizzo, è al centro del dibattito politico, economico e sociale di molti paesi e molto spesso non ha trovato soluzioni univoche.
Tasse e proprietà dei beni pubblici
Le tasse dovrebbero essere utilizzate per realizzare opere e fornire servizi, utili per i contribuenti.
In un secondo momento, sorge il problema della proprietà delle opere, e di chi abbia eventualmente il diritto ad incassare un prezzo dai servizi finanziati con le tasse.
La proprietà di un bene è solitamente in capo a chi ne ha sostenuto l'onere finanziario. Analogamente, la proprietà di un'opera pubblica o di un servizio pagato con le tasse dei contribuenti dovrebbe essere in capo allo Stato, che rappresenta gli stessi finanziatori-contribuenti.
Gli eventuali utili dovrebbero essere corrisposti ai proprietari nella forma di un reinvestimento per migliorare il servizio oppure distribuiti in termini di uno sconto fiscale o di una somma direttamente erogabile. Questi diritti sono elementi che distinguono proprietà e gestione sia di beni pubblici che privati.
Dirigenti e politici che ricevono in gestione tali forme di bene pubblico hanno comunque piena discrezionalità su scelte che riguardano l'assetto proprietario, quali la privatizzazione o trasferimento ad altri enti pubblici dell'opera. Decisioni di questo tipo, invece, in un'azienda privata richiedono un parere vincolante dei proprietari.
Fra le proposte di tassazione ad aliquota unica, quella della tassazione sull'utilizzo dei terreni, muove da considerazioni riguardo il bene pubblico.
Nel 1933, l'economista americano Henry George pubblica "Progress and poverty", nel quale propone una tassazione unica dei possidenti terrieri e l'abolizione di qualsiasi tassazione sul reddito, profitto o sul lavoro. Il presupposto era quello che la terra è di proprietà dell'intera collettività, ragione per cui il privato dovrebbe cedere parte della rendita allo stato con un contributo per l'occupazione del suolo pubblico.
Il "Single Tax Movement" che ne nacque aveva lo scopo di incoraggiare gli investimenti nei fattori della produzione esenti da tasse, il capitale e il lavoro, facendo pagare l'utilizzo del suolo pubblico, indipendentemente dalla capacità del singolo di utilizzarlo in modo efficiente e di trarvi un profitto.
Prelievo diretto e tassa da inflazione
Il debito pubblico è la risultante della differenza di entrate e uscite. Le entrate possono essere aumentate con un incremento delle tasse oppure con nuovo debito. Lo Stato, in questo secondo caso, emette nuovi titoli di debito in cambio di moneta, e si impegna a pagare i relativi interessi.
Ne deriva una "tassa da inflazione" per la quale il contribuente incontra un aumento dei prezzi in conseguenza dell'aumento dell'offerta di moneta circolante. Rispetto al prelievo diretto, il finanziamento della spesa pubblica con l'emissione di nuovi debiti, ha un costo maggiore legato agli interessi da ripagare i titoli di Stato, ed eventualmente ai nuovi debiti da contrarre per onorare tali interessi.
Se la decisione di finanziare la spesa in deficit spetta ai Governi, col veto della Banca Centrale, esiste una deroga al principio del "no taxation withoput rapresentation", che il potere politico può comunque usare laddove le ragioni del prelievo diretto non sono condivise dai cittadini.
La tassa può essere collegata anche ad un provvedimento amministrativo (tassa sul passaporto, sulla patente, sul porto d'armi; tasse sulle concessioni governative).
L'indicatore della pressione fiscale non considera la cosiddetta tassa da inflazione, essendo pari al rapporto fra le entrate e il PIL.
Non esiste un limite massimo all'aliquota per il prelievo fiscale, indipendentemente dalla fascia di reddito, ma solamente quello definito di volta in volta dalle normative fiscali. Una possibile soglia critica si può individuare intorno ad un'aliquota massima del 50%, che equivarrebbe a dire che il contribuente lavora 6 mesi all'anno per lo Stato.
In questo caso, la finalità al bene comune che dovrebbe avere il prelievo fiscale lederebbe i diritti di proprietà di una persona sulla ricchezza da essa prodotta.
Evasione fiscale [modifica]
I 2/3 dei contribuenti italiani nel 2006 hanno dichiarato un reddito da 6.000 a 15.000 Euro all'anno. Solo in 50.000 dichiarano più di 200.000 euro all'anno e 150.000 persone tra 100.000 e i 200.000.
I redditi da lavoro dipendente sono soggetti per legge, fin dagli anni '30, alla trattenuta alla fonte, e materialmente non possono evadere le tasse; da essi deriva la quasi totalità del gettito fiscale. L'evasione fiscale è vista come un'iniquità sociale tra lavoratori in quanto gli autonomi e i professionisti sono le categorie a più forte evasione.
In Italia contribuisce al fenomeno l'elevato numero di aziende che ancora non hanno integrato sistema informativo e sistema contabile tra loro e con i soggetti esterni (banche, clienti e fornitori) in modo che il pagamento dell'IVA e altre imposte avvenga tramite conto corrente e in automatico non appena sono generati ordini e pagamenti. Invece, in questi casi, si preferisce utilizzare bonifici o il pagamento in banconote contanti, anche di ingenti somme.
Altre modalità diffuse di evasione sono:
- la fuga di capitali in Paesi dove la tassazione è più favorevole, con l'investimento o il trasferimento dei beni mobili in conti esteri
- il deposito in cassette di sicurezza, anonime, delle quali solo il possessore ha la chiave di apertura, e dunque non tracciate in una banca dati interna dell'istituto, eventualmente accessibile alle autorità del fisco, né direttamente perquisibili dall'erario.
- l'intestazione dei beni, in particolare immobili, a società anonime di diritto estero, aventi sede legale fuori dell'Italia, senza dipendenti e con soci anonimi, prive di un capitale sociale minimo da versare sul quale rivalersi, e di riferimenti a persone fisiche, società alle quali una tassazione (e le sanzioni per l'evasione) sono in concreto applicabili con difficoltà.
Negli USA l'evasione fiscale è reato e i controlli sono affidati ad un'agenzia privata con novantamila addetti che devono vigilare su 200 milioni di contribuenti. L'agenzia ha il potere di ispezione sui conti correnti; in Italia invece deve essere inoltrata una richiesta a ognuna delle centinaia di banche esistenti per sapere se da qualche conto corrente ci sono stati degli accrediti o addebiti verso il numero di conto desiderato. In sostanza, non è visibile l'estratto conto presso la banca titolare del rapporto, ma deve essere ricostruito chiedendo alle altre banche tutte le movimentazioni in dare e in avere.
Contro questi poteri di controllo è stato sollevato il diritto alla privacy, sebbene a dati simili abbiano accesso anche piccole società di credito. Un secondo argomento è l'affido di poteri di polizia ad un soggetto privato, tanto più rilevante perché riguarda l'accertamento di un reato piuttosto che di un illecito amministrativo.

























